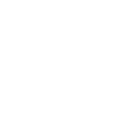La Kaaba
Dopo essere riuscito, a forza di calci violenti e di irose risposte a domande prudenti, a persuadere il portiere indiano stanco e sonnolento ad aprire l’enorme porta di quella specie di fortezza in cui vivevano i suoi genitori, Mohammed si è slanciato di corsa su per i gradini per andare ad abbracciare la madre. Un minuto dopo ho udito lo zaghritah o lululu, il grido penetrante con cui, in queste regioni, si saluta il ritorno a casa del viaggiatore.
Il giovane è tornato poco dopo, ma i suoi modi erano cambiati. Era passato dal comportamento disinvolto e turbolento che gli era abituale a quello grave e cortese del padrone di casa pieno di attenzioni nei miei riguardi. Mi ha guidato in un ingresso buio e mi ha fatto sedere su di una grande panca, una mastabah, ricoperta da un tappeto, poi ha chiesto al portiere, il bara Miyan, di portare una luce. Nel frattempo, il rumore di ciabatte strascicate al piano di sopra ha informato le mie orecchie attente che la kabirah, la signora della casa, era intenta ai suoi doveri di ospitalità. I cammelli erano appena stati scaricati quando abbiamo visto comparire un piatto di vermicelli caramellati e spolverati di zucchero. Mohammed, lo sceicco Nur ed io vi abbiamo immerso immediatamente la mano destra. Dopo le fatiche e le privazioni del viaggio, quei kunafah erano deliziosi. Terminato il pasto, abbiamo fatto venire dei letti mobili da un caffè vicino e ci siamo distesi con la speranza di dormire per un’ora o due, prima di affrontare il percorso del Tawaf al-Kudum verso il Santuario.
I primi raggi del sole cominciavano a dorare le cime rugose dell’Abu Kubays, la collina a est della Mecca, quando ci siamo alzati e abbiamo fatto il bagno. Abbiamo indossato l’abito del pellegrino e ci siamo diretti al Santuario, entrando dalla Bab-El-Ziyadah, la porta principale a settentrione. Abbiamo sceso due lunghe scale, abbiamo attraversato il chiostro e ci siamo trovati davanti alla casa di Dio, cuore del mondo, centro della Mecca, venerata dagli Indù, oltre che dai Musulmani, luogo rivendicato da più religioni. Il mio lungo e faticoso pellegrinaggio era giunto al termine, i progetti e i desideri di molti e molti anni si erano realizzati. La mia fantasia rivestiva di un fascino particolare quell’enorme catafalco e il suo scuro baldacchino, anche se non c’erano i giganteschi frammenti dell’antichità più remota dell’Egitto, né i resti di una bellezza piena di grazia e di armonia della Grecia o dell’Italia, né la sontuosità barbara degli edifici dell’India. La vista era strana e unica al mondo. Pochi occidentali hanno contemplato questo celebre reliquiario e il pellegrino venuto dal Nord era il più emozionato fra gli adoratori che abbracciavano piangendo i drappeggi o che premevano il cuore palpitante contro la pietra. Era come se si stessero realizzando le leggende poetiche degli Arabi, come se fosse il vento delle ali degli angeli a gonfiare i drappeggi della Kaaba e non la dolce brezza del mattino. Ma i miei sentimenti avevano più a che fare con il mio orgoglio soddisfatto che con i sentimenti religiosi.
Mohammed mi ha concesso qualche minuto per me stesso, prima di avvertirmi che era venuto il momento di cominciare i giri di preghiera. Siamo entrati attraverso la Porta dei Figli di Shaybah, abbiamo sollevato le mani e recitato le suppliche di rito. Poi ci siamo diretti verso il pozzo Zemzem, dove abbiamo recitato la preghiera con i due inchini per la moschea, abbiamo bevuto una tazza dell’acqua sacra con cui i pellegrini rompono il digiuno e abbiamo fatto un’offerta ai portatori, affinché ne distribuissero anche ai poveri che non potevano pagarsela.
Quindi ci siamo diretti nell’angolo a sud est dell’edificio, dove si trova la famosa Pietra nera. Un cerchio d’oro massiccio o d’argento dorato circondava il bordo un po’ più basso, in cemento rosso scuro, inclinato verso il centro. La Kaaba sembra composta da una dozzina di pietre più piccole, unite dal cemento e formanti un ovale di circa diciassette o diciotto centimetri di diametro. Non abbiamo potuto avvicinarci, perciò abbiamo fatto le nostre devozioni da lontano, prima di intraprendere la serie delle circonvoluzioni. Poi abbiamo cominciato la cerimonia del Tawaf, compiendo sette giri – tre a passo veloce, tarammul, e quattro a passo lento, ta’ammul - lungo l’ovale di granito lucido che circonda la Kaaba. Nell’angolo meridionale, meno affollato, siamo riusciti a toccare il muro con la mano destra, seguendo l’esempio del Profeta, e abbiamo baciato la punta delle dita.
Poi, Mohammed si è mostrato all’altezza della situazione. Dopo essersi rivolto invano ai pellegrini, di cui si vedeva solo un mosaico di scapole e di occipiti, ha riunito una mezza dozzina di robusti abitanti del luogo e con il loro aiuto si è fatto largo a forza in quella moltitudine dalle gambe gracili. I beduini si rivoltavano come dei gatti selvatici, ma non avevano armi ed erano indeboliti da sei mesi senza latte. Ridotti com’erano a delle mummie viventi, avrei potuto affrontarne con successo una mezza dozzina da solo. Malgrado l’indignazione popolare, abbiamo raggiunto la Pietra e per almeno dieci minuti l’abbiamo baciata e vi abbiamo strofinato contro le mani e la fronte. Io ne ho approfittato per osservarla da vicino e mi sono convinto che si tratta di un aerolito. Molti viaggiatori concordano sul fatto che la pietra sia di origine vulcanica. Secondo Ali Bey è “un blocco di basalto vulcanico, la cui superficie è disseminata di piccoli cristalli”. Burckhardt pensa che sia “un pezzo di lava contenente alcune particelle estranee di una sostanza bianchiccia e giallastra”. Ci siamo diretti verso un luogo chiamato al-Multazem e qui abbiamo nuovamente premuto lo stomaco, il torace e la guancia destra contro la Kaaba, recitando la preghiera di rito. Abbiamo anche chiesto perdono e pregato perché i desideri espressi dalle nostre anime fossero esauditi.
All’uscita ho mandato giù un’altra sorsata di acqua nauseabonda e ho ricevuto il contenuto di due o tre otri versati sulla mia testa en douche. Questa abluzione ha il potere di far cadere i peccati dallo spirito, come se fossero dei granelli di polvere. Poi siamo tornati verso la Pietra nera e abbiamo ripetuto le preghiere mentre la contemplavamo da lontano. Avremmo ancora dovuto compiere la cerimonia detta al-Sai, che consiste nel coprire per sette volte correndo la distanza fra i monti Safa e Marwah, ma eravamo sfiniti e questa impresa era fuori questione. Ho lasciato la moschea con i piedi feriti e con la testa che scottava a causa dei raggi infuocati del sole.
La sera sono tornato all’Ombelico del Mondo in compagnia di Mohammed e dello sceicco Nur, che portava una lanterna e un tappeto per la preghiera. Ci sono tornato per motivi estetici, per godere delle delizie della notte, dopo le sofferenze del giorno. La luna quasi piena illuminava la collina di Abu Kubays e riempiva di una luce solenne la scena. L’edificio aveva l’aspetto di una enorme tomba nera, con dei lampi argentei sotto i raggi della luna. Accanto ad esso, le cupole e gli edifici vicini a forma di pagoda sparivano. Il tempio sublime dell’unico Dio, il Dio di Abramo, di Ismaele e dei suoi posteri si stagliava sublime nella sua unicità ed esprimeva con l’eloquenza della fantasia la grandezza dell’Idea Divina, che ha dato vita all’Islam e che continua a dar forza e fermezza ai suoi seguaci.
Lo spazio ovale intorno alla Kaaba era pieno di gruppi di uomini, di donne e di bambini, che eseguivano un mutawwif. Alcuni camminavano a passo lento, altri correvano, altri ancora erano fermi a pregare. C’era una donna beduina, coperta da un abito monacale nero e da un velo rosso, forato, che lasciava passare i lampi selvaggi del suo sguardo. Una donna indiana, dai tratti quasi tartari, si affrettava a fare il giro del Santuario con le gambe sottili avvolte nelle calze spiegazzate. Ogni tanto passavano quattro uomini che portavano una barella di legno con un cadavere, poi sostituiti da altri quattro, secondo l’usanza. Alcuni Turchi dalla pelle bianca e dall’espressione fredda e ripugnante bighellonavano in giro. Un khitmugar di Calcutta, con le mani sui fianchi e il turbante di traverso, contemplava la scena con aria impassibile, com’è nello stile di quei gentiluomini. Un povero disgraziato con le braccia alzate si sforzava di toccare la Kaaba con tutte le parti del corpo e si appendeva ai drappeggi singhiozzando, come se gli si spezzasse il cuore a ogni momento.
Alle 10 del mattino del 12 settembre siamo partiti per il monte Arafat, che si trova a 12 miglia a est della Mecca. Lo sceicco Ma’sud era in piedi sin dall’alba davanti alla nostra porta, impaziente di partire prima che le carovane d’Egitto e di Baghdad rendessero pericolosa la strada. Il ritardo era dovuto all’ostinazione tirannica di Mohammed, che non voleva portare con sé il nipotino. Quando alla fine ha acconsentito, il bambino piangeva amaramente. Allora l’ho messo nella lettiga in mezzo a noi, così abbiamo potuto partire.
La strada era affollata di pellegrini in abito bianco, con la testa e i piedi nudi. Le persone benestanti cavalcavano degli asini, i beduini montavano dei veloci dromedari, i dignitari turchi dei magnifici cavalli. Fra tutti, però, i personaggi più pittoreschi erano i mendicanti. Ai lati della strada giacevano carcasse di animali, mentre altre erano state gettate in una cisterna asciutta. Il cattivo odore costringeva a turarsi il naso.
Dopo aver superato la punta conica del monte Jabal Nur, siamo entrati in una pianura dai molti nomi, che ospitava dei luoghi di preghiera circondati da muri bianchi e delle cisterne di pietra vuote. Dal terreno affioravano, come ciuffi d’erba, delle punte di granito. Le pietre più grosse nascondevano degli scorpioni dalla coda ricurva, che fuggivano appena lo sceicco Mas’ud si avvicinava per mostrarceli. Alle undici ci siamo inerpicati su per una scalinata di pietra, un mudarraj, i cui gradini avevano una superficie di almeno trenta iarde. Poi siamo passati attraverso l’Akabah e siamo entrati nel vallone pietroso dove si trova Muna, chiamata più classicamente Mina.
Il villaggio di Muna, lungo e stretto, con case di fango e di pietra a un piano o due, dista tre miglia dalla Mecca ed è una dimora di grande santità. Dopo averlo superato, siamo giunti nello spazio aperto dove sorge la moschea al Khayf sotto la quale, secondo qualche arabo, è sepolto Adamo, con la testa vicino all’estremità di uno dei muri laterali, i piedi vicino all’altra e la regione ombelicale sotto la cupola. A mezzogiorno abbiamo raggiunto il muzdalifah, un luogo dedicato alle cerimonie religiose, conosciuto come il minareto senza moschea, a metà strada fra Muna e Arafat. Colpisce l’aspetto di questa torre alta che si erge solitaria sopra alla terra desolata, sullo sfondo di contrafforti di roccia gialla. Ci siamo fermati per recitare la preghiera di mezzogiorno e siamo stati raggiunti dalla carovana di Damasco.
Dopo 6 ore lungo la strada Taif siamo arrivati ad Arafat. I cammelli erano esausti, gli uomini ancora di più. Fra Muna e Arafat ho visto almeno cinque uomini cadere e morire ai bordi della strada. Si erano trascinati penosamente fin là per rendere l’anima a Dio nel luogo da cui essa sale immediatamente verso la beatitudine eterna. Era la dimostrazione di come fosse facile morire a quelle latitudini! Gli uomini si accasciavano al suolo come fulminati da un colpo di fucile e, dopo una breve convulsione, restavano immobili come il marmo. I cadaveri venivano raccolti e sepolti con incuria la sera stessa in qualche spazio della pianura lasciato libero dalle tende.
Il giovane Mohammed aveva portato con sé due cugini di sedici e diciassette anni e i quattro servitori indiani di sua madre, un vecchio, sua moglie, il figlio e un suo amico. Costui aveva una storia molto interessante. Una notte gli era apparso in sogno Hazrat Ali, vestito di verde, sul suo destriero da battaglia Duldul, e gli aveva gridato con voce terribile: “Per quanto tempo ancora continuerai ad affannarti dietro alle cose terrene e a disinteressarti della vita eterna?” Da quel momento, braccato dalla sua coscienza e da Hazrat Ali, egli non ha più avuto pace. Trovando insopportabile la vita a casa, dove si guadagnava onestamente da vivere, ha venduto tutto, ha messo insieme una somma di venti sterline ed è partito per la Terra Santa. A Gedda gli erano rimaste solo poche rupie. Alla Mecca, dove i prezzi sono esorbitanti e la carità è sconosciuta, sarebbe morto di fame se non fosse stato accolto in casa dal suo amico, la cui madre ha preso a servizio tutta la famigliola, in cambio dell’ospitalità e di quattro libbre di riso al giorno. A procurarsi le cipolle e lo zafferano dovevano pensarci loro. Quei poveri disgraziati attendevano ansiosamente l’occasione di andare a Medina, senza la quale il pellegrinaggio non sarebbe stato completo. Erano pronti a chiedere l’elemosina in pieno deserto, esponendosi al pericolo dei beduini. Che speranze avevano quel vecchio, quella donna e quel ragazzo di rivedere il proprio paese?
Arafat, anticamente detta Jabal Ilal, il Monte della Lotta nella Preghiera o Jabal al-Rahmah, ovvero Monte della Misericordia, è una massa di granito ricoperta da spine aguzze con una circonferenza di circa un miglio, che si erge bruscamente al di sopra della pianura ghiaiosa fino a un’altezza di 180-200 piedi. La vista dell’accampamento nella pianura e delle cime azzurrognole dei monti Taif sullo sfondo era qualcosa di molto pittoresco. Secondo i miei calcoli, nelle tende c’erano almeno cinquantamila persone di ogni sesso ed età.
La Collina Sacra deve i suoi onori a una leggenda. I nostri progenitori, privati del paradiso per aver mangiato frumento, furono precipitati sulla terra dopo aver perso la purezza primitiva. Eva è caduta sull’Arafat, Adamo sopra Ceylon, il serpente sopra Ispahan, il pavone reale sopra Kabul e Satana a Bilbays, anche se altri dicono a Semnan o a Seistan. Adamo si è messo in viaggio per ritrovare sua moglie ed è a lui che la terra deve il suo aspetto attuale. Ovunque il nostro progenitore appoggiasse il suo grande piede sorgeva una città, mentre lo spazio fra un passo e l’altro rimaneva campagna. Adamo ha vagato per molti anni, fino a quando è giunto alla Montagna della Misericordia, dove la nostra madre comune continuava a chiamarlo. Il loro riconoscimento reciproco ha dato origine al nome Arafat. Istruito dall’arcangelo Gabriele, Adamo ha costruito in cima una mada’a, un luogo di preghiera. La coppia ha passato il resto dei propri giorni fra questo e la moschea Nimza. Altri ritengono che Adamo ed Eva siano andati a vivere in India, tornando poi a visitare la Città Santa nel periodo del pellegrinaggio per i 44 anni successivi.
Sono sceso giù dalla collina per osservare il bivacco da vicino. Mi ha colpito la differenza fra la zona delle tende della gente di città, sporca e puzzolente, e quella più pulita dei beduini. Il povero Ma’sud non cessava di tapparsi il naso ed era talmente felice della mia osservazione che, battendomi la mano sulla spalla, mi ha detto: “Hai ragione, o Padre di tutti i Baffoni, e per mostrarti quanto ciò sia vero ti porterò a vedere le tende della mia tribù!”
Quando è scesa la notte ci siamo gettati sui nostri tappeti, ma non siamo riusciti a dormire perché la pianura risuonava delle preghiere, dei canti dei pellegrini, e di tutti i rumori provenienti dai caffè.
La mattina di martedì 13 settembre, nono giorno dello Zu’l Hijjah, è cominciata con rumori militari. Una scarica di colpi di cannone ci ha avvertiti che dovevamo alzarci e prepararci alle cerimonie. Dopo l’abluzione e la preghiera, Mohammed e io ci siamo messi in cammino per andare a visitare i luoghi sacri della Montagna della Misericordia.
Dapprima ci siamo diretti verso una piccola altura, a un centinaio di iarde a sud-est della collina, chiamata Jami al-Sakhrah, il Luogo di Riunione della Roccia. Qui, in piedi su due blocchi tondeggianti di granito, il Profeta aveva recitato la talbiyat. L’altura è circondata da un muro bianco quadrato, diviso in due sezioni per uomini e donne. Poi ci siamo fatti strada in mezzo alle tende e alle rocce e abbiamo cominciato a inerpicarci su per l’ampia scalinata di rozzi gradini, che saliva lungo il versante meridionale della collina. Malgrado l’ora, era già piena di pellegrini, soprattutto Beduini e Wahabiti, che si erano assicurati un buon posto per ascoltare il sermone. La loro bandiera verde era piantata accanto al luogo di preghiera di Adamo. A metà cammino ho contato 66 gradini, che diventavano più stretti e ripidi man mano che si saliva. Un secondo recinto segnava il punto in cui Maometto si indirizzava ai suoi seguaci. I predicatori di oggi, i khetib, vi impartiscono il sermone di Arafat dall’alto dei loro dromedari.
Con difficoltà abbiamo raggiunto la cima, dove c’era un’ampia piattaforma rivestita di stucco, con una nicchia per la preghiera e un makan, una specie di obelisco bianco di granito e di pietra calcarea, visibile da molto lontano. Abbiamo visto anche la sorgente che fornisce l’acqua ai pellegrini, sicuramente molto pura.
Suonavano le nove quando abbiamo raggiunto la pianura, dove erano tutti in uno stato di grande agitazione. Il cannone sparava senza interruzione, i cavalieri e i cammellieri galoppavano in tutte le direzioni, le donne vagavano qua e là, i bambini erano troppo inquieti per riuscire a dormire. Noi abbiamo fatto colazione il più tardi possibile, perché sapevamo di non poter più mangiare fino a notte. Dopo la preghiera di mezzogiorno, abbiamo fatto le abluzioni in mezzo a un rumore crescente. Alle tre e un quarto, una nuova scarica di cannonate ha annunciato l’avvicinarsi dell’Asr, la preghiera del pomeriggio e, subito dopo, abbiamo sentito il suono della banda che precedeva la comitiva dello sceriffo, diretta alla montagna. Fortunatamente, la mia tenda si trovava vicino alla strada, così ho potuto seguirne il passaggio senza problemi.
In testa c’era un nugolo di mazzieri che si aprivano la strada senza tante cerimonie. Essi erano seguiti dai cavalieri del deserto con le lunghe lance infiocchettate. Dietro venivano i cavalli dello sceriffo, piccoli e di gran razza, uno dei quali, di colore marrone e nero, mi è sembrato un esemplare perfetto di purosangue arabo. Seguiva un gruppo di schiavi neri a piedi, con in mano degli enormi fucili a miccia. Infine, preceduto da tre bandiere verdi e da due bandiere rosse, avanzava lo sceriffo, alla testa della sua famiglia e dei cortigiani. Il principe aveva la testa nuda, indossava l’abito bianco del pellegrino e cavalcava una mula. L’unico segno del suo rango era un parasole verde ricamato d’oro retto da uno schiavo. Chiudeva il corteo una schiera di beduini a cavallo e sui cammelli.
Lentamente e solennemente, le processioni marciavano verso la collina. I componenti di quella dello sceriffo, una volta giunti in cima, si sono disposti a portata di voce del predicatore. Gli altri pellegrini, invece, si sono fermati più in basso. Al tumulto e allo sventolio di abiti bianchi era seguito un silenzio solenne. Dalla mia tenda potevo distinguere la sagoma del vecchio che stava per pronunciare il sermone dall’alto del suo cammello ma la distanza era troppo grande per udirlo. La predica durava generalmente tre ore, fino al tramonto del sole. All’inizio tutti seguivano in profondo silenzio, poi, a poco a poco, le urla di amen e di labbayk si facevano sempre più frequenti, fino ad essere continue, accompagnate da pianti e singhiozzi. Fra i miei compagni che si sentivano in dovere di partecipare all’emozione generale, almeno esteriormente, il vecchio Ali si asciugava gli occhi. Mohammed, invece, nascondeva il viso fra le pieghe dell’abito. Almeno un’ora prima della fine del sermone, la folla, sfinita dalle emozioni, cominciava a scendere a piccoli gruppi. Quelli più in basso smontavano le tende, caricavano i cammelli e si affrettavano il più possibile perché nessun beduino amava trovarsi nella calca creata che si crea nello scendere dall’Arafat. Anche noi ci siamo preparati, ma non siamo riusciti ad avere le bestie pronte prima che il predicatore desse il segnale della partenza, l’israf. Ho assistito così alla scena che porta il nome di al-daf’a min Arafat, ‘via in fretta dall’Arafat’. Come onde di un mare ingrossato, i pellegrini si precipitavano giù per la collina emettendo dei ‘labbayk’ forti come delle esplosioni. Tutti spingevano a forte andatura le proprie bestie, che inciampavano nei cavi delle tende di cui era irta la pianura. Le lettighe si sfasciavano, i pedoni venivano calpestati, i cammelli rovesciavano il carico, gli uomini litigavano anche con i bastoni, le donne e i bambini si smarrivano. Era un caos totale.
Faceva buio quando abbiamo riattraversato la gola all’uscita dalla pianura di Arafat. Nessuno sembrava avere il controllo dei propri atti e i cammelli e le lettighe si scontravano con un fracasso di torrenti in piena. I colpi di cannone e la pioggia di razzi sfavillanti accrescevano la confusione e terrorizzavano le donne e i bambini. Dalle file delle truppe regolari veniva una musica marziale e alcuni pellegrini gridavano a pieni polmoni: “Che il tuo giorno di festa sia felice!”Oltre il passo delle Due Colline Accidentate, la strada si allargava e il pericolo diminuiva. Dopo tre ore di marcia estenuante, siamo arrivati alla moschea Muzdalifah, e, poiché eravamo morti di fatica, abbiamo deciso di passarvi la notte. L’edificio era brillantemente illuminato, ma i miei affamati compagni pensavano di più al cibo e al sonno che alla preghiera. Dopo aver mangiato la cena che gli Indiani ci avevano preparato e prima di andare a dormire, tuttavia, abbiamo raccolto sette ciottoli di granito, i jamrah, della dimensione di un fagiolo. Poi abbiamo bevuto il caffè, fumato la pipa e ci siamo sdraiati sui tappeti, anche se la notte era troppo rumorosa per poter dormire. Ogni dieci minuti passavano carovane di cammelli e si sentivano le urla dei viaggiatori, che sono continuate fino all’alba. Anche il giovane Mohammed è partito in direzione di Muna, per scegliere un posto dove montare la tenda.
L’indomani mattina ci siamo alzati appena abbiamo udito il colpo di cannone che ci avvertiva di non perdere tempo. Era l’alba dell’Id al-Kurban, il 14 settembre. Siamo arrivati a Muna verso le 8 e ci siamo messi alla ricerca di Mohammed, una ricerca piuttosto difficoltosa. È stato suo cugino a guidarci verso le falde del monte Sabir, dove il giovane aveva montato la tenda. Quando è ricomparso, ha detto che il motivo del ritardo era stata la difficoltà di trovare degli asini per noi.
Come atto preliminare, ci siamo lavati con le “sette acque”, cioè con le sette pietre che avevamo raccolto a Muzdalifah e conservato in un angolo annodato del nostro ihram, l’abito da pellegrino. Poi ci siamo diretti verso l’estremità occidentale della lunga fila di case di cui si compone il villaggio di Muna, dove sorge il Jamrat al-Akabah o, come è volgarmente chiamato, lo Shaytan al-Kabir, il pilastro che rappresenta Satana il Grande. È un contrafforte di muratura grezza, alto otto piedi, largo due e mezzo, che poggia sul muro di cinta di pietra, accanto all’ingresso in città dalla Mecca. Qui si svolge la cerimonia del Ramy o della Lapidazione, che si effettua anche in altri due luoghi: uno, al centro del villaggio, il Wusta, l’altro, all’estremità orientale, l’Aula.
Lo stretto spazio era reso pericoloso dall’enorme folla di pellegrini che lo riempiva. Le teste erano talmente vicine che vi si sarebbe potuto camminare sopra come su un pavimento. Fra di loro c’erano dei cavalieri che montavano cavalli focosi, dei beduini in groppa a cammelli selvatici, dei dignitari sopra a muli e asini, a cui i battistrada cercavano di aprire un passaggio a viva forza. Il mio asino era appena penetrato tra la folla quando è stato travolto da un dromedario, sotto il cui stomaco mi sono ritrovato all’improvviso. Per fortuna avevo con me un pugnale e il saggio uso che ne ho fatto mi ha impedito di essere calpestato. Non ho perso tempo ad allontanarmi velocemente da quel luogo pericoloso. Anche Mohammed ne è uscito con il naso sanguinante. Ci siamo seduti entrambi su di una panca davanti alla baracca di un barbiere e abbiamo atteso con pazienza un momento più favorevole per avvicinarci.
Quando, approfittando di un’apertura tra la folla, siamo riusciti ad arrivare a circa cinque cubiti dal pilastro, abbiamo gettato le nostre sette pietre, tenendole fra il pollice e l’indice della mano destra. Ogni volta abbiamo esclamato: “Nel nome di Allah, l’Onnipotente, faccio questo in odio al diavolo e per sua vergogna!” e abbiamo recitato le preghiere di rito.
Poi ci siamo ritirati nella fresca baracca del barbiere per farci rasare la testa, spuntare la barba e tagliare le unghie. Da quel momento saremmo stati liberi di abbandonare l’abito da pellegrino, ma purtroppo non ne avevamo uno di ricambio. Potevamo anche coprirci la testa, indossare le pantofole per proteggere i piedi dal calore del sole, attorcigliare i baffi e accarezzarci la barba, tutte cose di cui la Legge del Pellegrinaggio ci aveva privati. Alle undici abbiamo fatto ritorno verso la Mecca, compiendo l’al-nafr, cioè il volo.
Eravamo da poco rientrati a casa quando Mohammed mi ha gridato di rivestirmi in fretta e di seguirlo. In quel momento, la Ka’abah era aperta, ma ancora vuota all’interno. Ho rimesso il mio costume da pellegrino e siamo usciti senza perdere tempo. Intorno all’edificio c’era molta folla e io non me la sentivo di stare sotto il sole cocente di mezzogiorno con la testa e i piedi nudi.
A un certo punto, qualcuno ha esclamato: “Fate largo al pellegrino che vuole visitare la Casa!” Due uomini vigorosi, che erano in piedi accanto alla porta, mi hanno sollevato in alto e un terzo mi ha scaraventato dentro. Mi sono ritrovato circondato da funzionari di pelle scura, il più brutto e il più nero dei quali era un giovane della famiglia dei Bani- Shaybah, il sangre-azul, il sangue blu dell’Hijaz. Si è seduto su un armadietto di legno e ha cominciato a pormi delle domande precise sulla mia identità, sul mio paese e su tanti particolari. Le mie risposte devono averlo soddisfatto perché ha ordinato a Mohammed di farmi entrare e di guidarmi nei vari giri di preghiere. Devo ammettere che guardando quei muri senza finestre, i funzionari sulla porta, la folla dei fanatici esaltati che mi circondava, ho provato la sensazione del topo preso in trappola. Questo non mi ha tuttavia impedito di guardarmi intorno attentamente e di tracciare sul mio abito bianco una mappa dell’interno, che, peraltro, è molto semplice. Il pavimento, posto al livello del suolo, era composto di splendidi marmi di colori diversi, disposti a scacchiera. Le mura, per quanto ho potuto vedere, erano anch’esse ricoperte di marmi dalla forma irregolare, con lunghe iscrizioni in caratteri moderni. La parte superiore delle pareti e il soffitto, che era proibito guardare per non mancare di rispetto, erano rivestiti di un bel damasco rosso, ricamato a fiori d’oro. Il tetto era sorretto da tre travi trasversali, di cui si indovinava la forma sotto la tappezzeria, sostenute al centro da tre pilastri ricoperti di legno di aloe intarsiato. Fra una colonna e l’altra, a circa nove piedi dal pavimento, correvano delle barre di un metallo che non sono riuscito a identificare, alle quali erano appese molte lampade, che si diceva fossero d’oro. Anche se nella Kaaba erano presenti solo alcuni servitori che preparavano l’ambiente per la visita dei pellegrini, le pareti senza finestre e la porta chiusa la rendevano peggiore dei Piombi di Venezia. Il senso di soffocamento e il caldo erano insopportabili. Io grondavo sudore e mi chiedevo con orrore come dovesse essere il posto quando era pieno di fanatici furiosi che si facevano largo a gomitate e si schiacciavano a vicenda. Dopo aver compiuto le devozioni, mi sono diretto verso la porta, dove si doveva versare una quota di denaro, che Mohammed mi ha detto essere di sette dollari. In realtà ne sono stati chiesti di più, ma io, che mi aspettavo una cosa del genere, ne avevo portati con me solo otto.
Mohammed si ostinava a proclamare ai quattro venti che ero un pellegrino indiano ricco e generoso, di conseguenza venivo strattonato e sottoposto a ulteriori richieste di soldi. Molti pellegrini rifiutano di entrare nella Kaaba per motivi religiosi e di coscienza. Fra gli altri doveri, infatti, si contrae quello di non andare più a piedi nudi, di non toccare il fuoco con le dita e di non dire bugie. Molti uomini non si possono permettere il lusso delle babbucce né della verità. Il servitore di uno dei miei amici di Bombay mi aveva detto di non essere entrato nella Kaaba perché si sarebbe rovinato. Non aveva torto. Agli Orientali, la menzogna dà da bere, da mangiare e un tetto per ripararsi.
La Kaaba era appena stata ricoperta di un nuovo drappo che pendeva dal soffitto con l’ausilio di alcune corde e aveva due punte su ogni facciata. Era di un nero brillante, con una frangia dorata, lo hizam, che correva lungo la parte superiore dell’edificio e un velo teso sulla porta come su di un viso. L’origine di questa usanza potrebbe risalire all’antica pratica di raffigurare la chiesa visibile come una vergine o una sposa. Il poeta musulmano Abd al-Rahim al Bura’i ha reso in un suo verso questa idea.
La sera, dopo esserci riposati e aver indossato degli abiti ‘laici’ ma adeguati al Grande Festival, siamo risaliti sui nostri asini e siamo tornati a Muna, dove abbiamo trovato la nostra tenda piena di visitatori. Abbiamo conversato con loro per quasi un’ora e, quando sono ripartiti, abbiamo continuato a parlare fra di noi della pratica del sacrificio. Era usanza immolare una vittima subito dopo la prima lapidazione, ma, date le magre condizioni del mio portafoglio, avevo deciso di non acquistare alcuna pecora e di limitarmi a osservare i sacrifici dei miei vicini. Si davano tutti un gran da fare per comprare l’animale al prezzo più basso possibile. Fra di loro c’erano alcuni Indiani nostri vicini, che avevano contrattato a lungo il loro acquisto. Qualcuno aveva comprato un bue molto magro e solo lo sceriffo e gli alti dignitari sacrificavano un cammello. I pellegrini trascinavano le loro vittime fino a una roccia vicino all’Akabah, al di sopra della quale c’era un piccolo padiglione i cui muri erano rossi di sangue fresco. Qualcuno immolava gli animali davanti alla propria tenda, girando loro la testa verso la Kaaba prima di sgozzarli e pronunciando la formula: “Bismillah! Allah Akbar!”. Era considerato atto meritorio abbandonare le bestie senza toccarle. A sgozzarle e a farle a pezzi provvedevano i Takruri, fermi, come tanti avvoltoi, nell’attesa di ricevere il segnale per farlo. Ben presto la valle aveva assunto l’aspetto di un mattatoio sporco e pieno di sangue. Era facile presagire che ben presto l’aria, completamente immobile in quel bacino dalla forma simile al cratere di un vulcano, sarebbe stata irrespirabile.
La notte seguente non sono riuscito a chiudere occhio e, con il pretesto di sorvegliare le tende, sono rimasto seduto fuori al chiaro di luna. Dopo mezzanotte, siamo andati a compiere una seconda lapidazione ai tre pilastri, cominciando dall’Ula, all’estremità orientale.
All’alba di giovedì 15 settembre abbiamo fatto una colazione leggera in vista della faticosa arrampicata che ci attendeva. Ai piedi del monte Jabal Sabir, c’era un piccolo Majarr al-Kabsh, un spazio quadrato circondato da muri bianchi e diviso in due compartimenti. Nel primo c’era un blocco di granito con una fenditura larga diversi pollici e profonda alcuni piedi, che gli dava la forma di una lama di coltello. E’ il luogo dove è caduta la spada di Abramo quando l’arcangelo Gabriele gli ha proibito di uccidere il proprio figlio Ismail. Il secondo compartimento conteneva un piccolo ipogeo, in cui si dice che il patriarca abbia immolato la vittima che dà il nome al luogo. Data l’ora mattutina, vi erano ancora posti liberi sui tappeti e sui materassi e noi abbiamo potuto recitare le nostre preghiere con relativa tranquillità. Poi siamo saliti in cima alla collina, nella speranza di vedere alcune delle scimmie che sembra vivano ancora lì, ma non ne abbiamo scorte. Quindi ci siamo affrettati a riguadagnare le nostre tende prima che il calore del giorno diventasse insopportabile. Ci aspettavamo una giornata terribile e non ci siamo sbagliati. Al caldo sono venuti ad aggiungersi i nugoli di mosche e gli odori putridi emananti dal suolo imbevuto di sangue. A parte i nibbi e gli avvoltoi non si muoveva nulla, e gli abitanti della terra, sembravano paralizzati dal fuoco che giungeva dall’alto.
Quando è sorta la luna, Mohammed e io siamo tornati a Muna a compiere l’ultima lapidazione. Sulla via del ritorno, abbiamo udito dei canti e un rumore di battimani. Abbiamo visto una folla di beduini dediti alla loro attività preferita, la danza. Era una rappresentazione estremamente selvaggia, con dei movimenti che somigliavano più ai salti degli orsi che a delle evoluzioni ispirate da Tersicore. Il canto era un interminabile recitativo in chiave minore, comune presso gli Orientali, con un refrain a cui nessuno sembrava in grado di attribuire un significato.
Il venerdì mattina all’alba abbiamo caricato in fretta i cammelli. Eravamo ansiosi di tornare alla Mecca in tempo per il sermone. Inoltre, non vedevo l’ora di fuggire da quel luogo la cui aria era diventata pestilenziale. In quella Scodella del Diavolo erano state uccise cinque o seimila bestie, che si stavano decomponendo. Per porre rimedio al cattivo odore, si sarebbero dovuti costruire degli abattoirs o dare ordine di non fare i sacrifici in un solo luogo. Ma lo spirito dell’Islam si oppone ai suggerimenti dettati dal buon senso. Alla Mecca, quartier generale della fede, si preferisce un’epidemia di colera all’empietà di opporsi ai decreti della Provvidenza.
Ripassando per Muna, ho gettato dall’alto della lettiga gli ultimi ventuno sassolini rimastimi contro i pilastri del diavolo. Per strada c’erano già molte persone, che, come noi, abbandonavano la valle e lo spettacolo rivoltante che offriva. Provavo pietà per gli sfortunati trattenuti in quel posto dagli scrupoli religiosi.
I miei ultimi giorni alla Mecca trascorrevano abbastanza piacevolmente. Purtroppo, tutte le informazioni prese concordavano nel definire impossibile il ritorno attraverso la penisola araba. I miei compagni, da parte loro, cominciavano a soffrire del mal de pays, e, passata l’emozione del viaggio, non potevano fare a meno di pensare alle mogli e ai figli. I visi lunghi e i sospiri continui indicavano la crescente nostalgia e il desiderio di tornare. Così, ben presto la nostra casa è diventata la sede dei preparativi per la partenza.
Il giorno dell’arrivo, dopo il bagno rituale, eravamo andati al Santuario ad ascoltare il sermone. Il vasto quadrilatero era pieno di devoti seduti in lunghe file di fronte alla torre centrale nera. I fiori più colorati di un giardino non avrebbero potuto superare la vivacità del loro abbigliamento. Solo le donne erano vestite di scuro e si tenevano in disparte nell’area riservata a loro. Tutti erano immobili, ad eccezione di alcuni dervisci che andavano in giro con il turibolo in mano e ricevevano l’elemosina senza chiederla. Il pinnacolo dorato del pulpito dove era seduto il predicatore, un vecchio dalla lunga barba bianca, con la testa coperta da un turbante e da un taylasan, rifletteva i raggi infuocati del sole. Dopo l’invito al sermone recitato dal muezzin, il predicatore ha detto: “La pace sia con voi, così come la misericordia e la benedizione di Allah”. Poi ha cominciato la predica. All’inizio, il silenzio era profondo, interrotto solo da qualche raro amen, ma, gradualmente, le voci si sono moltiplicate e, verso la fine, si sentiva l’alzarsi e l’abbassarsi continuo degli accenti di un coro formato da migliaia di persone. Tuttavia, anche se avevo già assistito a molte altre cerimonie religiose, nessuna mi aveva mai causato una simile impressione di solennità.
Prima di lasciare la città ho preso parte a una grande cena a casa del vecchio zemzemi Ali bin Ya Sin. Ci eravamo preparati al pasto fumando e bevendo caffè. La cena è stata servita su di un sini, un vassoio di rame placcato e ornato di arabeschi e di iscrizioni, sorretto da un kursi, uno sgabello di legno di sandalo con delle incrostazioni di madreperla, sul quale era anche sistemato un servizio dello stesso materiale del sini. Abbiamo cominciato con una varietà di stufati di carne con verdure, fra i quali gli spinaci e il bamiyah, l’hibiscus. Poi abbiamo affondato le mani nel biryani, il riso pilaf con la carne, abbondantemente impregnato di burro chiarificato. Abbiamo continuato quindi con il kimah, uno stufato di carne tagliata a piccoli pezzi e con il warak mahshi, consistente in foglie di vite farcite di carne di montone macinata e speziata, ripiegate a triangolo. Siamo quindi passati al kebab, accompagnato da una salatah di cetrioli freschi e croccanti e da un’anguria tagliata a dadini. Al posto del pane c’era una specie di focaccina orientale, migliore del chapati dell’India. Bevevamo dell’acqua profumata con la resina di Chio. Abbiamo proseguito il pasto con il kunafah, il piatto di vermicelli dolcificati con il miele e con lo zucchero in polvere, accompagnato da diverse composte di mele e da una gelatina liquida e profumata fatta di riso, farina, latte e amido e da quadrati di rohah, una confettura solida molto apprezzata perché viene da Costantinopoli. La frutta consisteva in semi di melagrana e di datteri dal sapore squisito. Abbiamo concluso la cena con il riso bollito e il burro, mangiato con dei cucchiai di legno. Gli Arabi ignorano la deliziosa arte francese di prolungare il pasto. Dopo essersi lavati le mani ed essersi seduti, si gettano sulle ginocchia un tovagliolo ricamato, pronunciano un bismillah per ringraziare Dio e immergono le mani nei piatti preferiti, cambiando ad libitum, leccandosi ogni tanto le dita o introducendo un boccone scelto nella bocca di un vicino.
Una volta soddisfatta la fame, non rimangono seduti in attesa che tutti i commensali abbiano terminato, ma si alzano da tavola gridando: “Al Hamd!”. Poi si lavano le mani e la bocca con il sapone, facendo mostra di essere sazi per non essere invitati a mangiare ancora, quindi afferrano la pipa, sorseggiano il caffè e si abbandonano al piacere del kaif. La serata si chiude con la preghiera.
Il ritorno agli affari e ai piaceri terreni hanno segnato la fine delle cerimonie del pellegrinaggio. La maggior parte dei devoti, ormai puri e senza macchia e con il libro dei peccati trasformato in una tabula rasa, si affrettavano ad aprirvi un nuovo capitolo. È piccolo il numero di quelli che il pellegrinaggio induce a cambiar vita. D’altra parte, è una cosa che avviene anche presso i Calvinisti, che ricominciano a peccare il lunedì, dopo aver passato la domenica a pregare e presso i Cattolici, che si confessano, si pentono, poi ripetono con fervore gli stessi errori.
Terminata la settimana santa, non vi era più nulla che mi trattenesse alla Mecca. Ho deciso dunque di partire per il Cairo e di fermarmi là qualche giorno. Perciò ho affittato due cammelli e ho affidato allo sceicco, ora haji Nur il mio bagaglio pesante, da portare a Jeddah. Ho detto addio a tutti gli amici e sono salito sull’asino, accompagnato da Mohammed.
Quando sono uscito nella pianura, ho provato un brivido di piacere, simile a quello che prova il carcerato quando viene liberato dalla sua prigione sotterranea. I raggi del sole mi scaldavano dandomi rinnovato vigore, l’aria del deserto era un balsamo per i miei polmoni. Il volto della natura era per me come il sorriso di un caro, vecchio amico ritrovato.