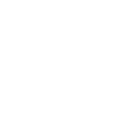DA SUEZ A YANBU
Abbiamo lasciato Tur all’alba dell’11 luglio 1853, con la sgradevole certezza che non avremmo toccato terra per le trentasei ore successive. Per trascorrere la giornata, esaminavo la trama del tessuto del mio grande ombrello e facevo considerazioni sul tempo.
Mattino. – L’aria era mite e balsamica, come quella di una primavera italiana. Una spessa foschia rotolava giù dalle valli verso il mare e una leggera nebbia madreperlacea coronava il promontori. In lontananza si vedevano le pareti titaniche, le guglie alte come torrioni, i bastioni sporgenti, le fosse profonde e ombrose dei monti. Ai loro piedi, il mare aveva il colore dell’ametista. Quest’ora era la cosa più deliziosa, ma poichè
“les plus belles choses
ont le pire destin” l’incanto si dissolveva in fretta. Il sole esplodeva alto sul mare, tingendo il cielo di arancione e il mare di viola, e, come un nemico, costringeva tutti ad acquattarsi davanti a lui. Dissolveva la foschia e metteva in fuga le nubi color agata che fino a un attimo prima avevano galleggiato nel firmamento. L’aria era così limpida che di tanto in tanto si vedeva un pianeta. Nelle due ore successive al sorgere del sole, i raggi erano sopportabili; poi, essi diventavano una tremenda ordalia e inducevano una sensazione di malessere. Il bagliore opprimente e continuo, riflesso dalla superficie abbagliante dell’acqua, accecava, produceva vesciche sulla pelle, seccava la bocca e mutava gli uomini in esseri monomaniaci. Non si faceva altro che contare, minuto per minuto, le lunghe ore che separavano dalla sera, quando ci si sentiva più sollevati.
Mezzogiorno. – Il vento, riverberato dalle ardenti colline, era come il soffio uscito da una fornace. Sotto alla canicola, i colori si confondevano. Il cielo era di un bianco latte mortale, il mare era come uno specchio nel quale era difficile distinguere la linea dell’orizzonte. Dopo mezzogiorno, il vento cessava e tutto era silenzioso e immobile. L’unico suono era dato dal malinconico sbattere delle vele. Gli uomini, più che addormentati, erano tramortiti dal caldo e avevano la sensazione che sarebbero bastati pochi gradi in più per morire.
Tramonto. – Il linguaggio è uno strumento troppo freddo e povero per descrivere l’armonia e la maestosità dell’ora, bella e evanescente, in cui il nemico scompariva al di là del mare ceruleo, sotto a un gigantesco arcobaleno, i cui colori andavano dall’arancione bronzeo al verde marino, che copriva metà del cielo. Verso oriente un bagliore purpureo dipingeva di un colore diverso le forme del deserto e quelle taglienti delle colline, facendole risaltare. Poi è scesa rapidamente la notte e sotto alla misteriosa luce della luna le colline, i pinnacoli e gli spuntoni di roccia apparivano bianchi e spettrali.
Notte. – Il mare rifletteva il bianco viso del sole notturno come uno specchio d’acciaio. Nell’aria erano visibili colonne gigantesche di luce chiara appoggiate alle onde e perdute nello spazio infinito. Le stelle brillavano di luce sovrana. In quell’ora
“Il fiume, la collina, il bosco
e le innumerevoli forme di vita, impercettibili come i sogni.”
I pianeti ci guardavano con le facce di amici sorridenti. Si sentiva la dolce influenza delle Pleiadi, ci si sentiva legati dal ‘laccio di Orione’, mentre Espero portava con sé migliaia di cose. In comunione con loro, le ore passavano veloci, finché la pesante rugiada spingeva a coprire il viso e dormire. Dopo un ultimo sguardo a una piccola stella del nord, sotto alla quale risiedeva tutto ciò per cui valeva la pena di vivere, si sprofondava nell’oblio.
Quando i raggi del sole hanno cominciato a cadere su di noi in modo innocuo, ci siamo alzati, ancora deboli e storditi, e abbiamo chiesto quell’acqua che fino a pochi minuti prima non avevamo avuto la forza di bere. Poi abbiamo acceso la pipa e sorseggiato il caffè. La nostra cucina, piuttosto primitiva, era costituita da una scatola di legno foderata di argilla, riempita di sabbia, con tre o quattro grosse pietre sul fondo per appoggiarvi le pentole. La cena frugale consisteva di solito in un po’ di riso, qualche dattero e una cipolla, quel tanto che bastava a tenerci in vita, dato che non avevamo mai molto appetito. Ma gli Arabi amano mangiare cibo caldo almeno una volta al giorno, perciò ci mettevamo a cucinare, nonostante la difficoltà creata da venti persone in lotta davanti a un unico fuoco.
La brezza che rinfrescava i nostri visi riarsi rinvigoriva in modo sorprendente anche il nostro spirito. Abbiamo cantato canzoni, raccontato storie, fatto circolare scherzi pesanti, che mettevano a dura prova la suscettibilità orientale. Poi abbiamo letto attentamente e devotamente lo ‘hizb al-bahr’, la preghiera che aiuta a salvarsi quando si è in pericolo. Quindi ci siamo coricati dentro alle spesse trapunte imbottite e ci siamo gettati alle spalle le difficoltà della giornata.
L’11 luglio siamo passati davanti alle famose rupes dell’Al-‘Akabah, che sono il terrore dei viaggiatori perché in qualsiasi momento davanti a esse può scoppiare una tempesta. Nell’attraversarne l’imboccatura, gli uomini hanno levato le braccia al cielo, in atto di preghiera e di supplica. Poi, per un giorno e una notte abbiamo visto solo cielo e mare e il nostro unico movimento era dato dallo sballottamento delle onde. All’alba del 13 luglio il battello, le cui vele si muovevano lentamente nell’aria quasi immobile, è scivolato verso il luogo di attracco. Quando con difficoltà abbiamo raggiunto il vicino porto di Wijh, i nostri visi si sono illuminati.
Gli abitanti del piccolo villaggio formato da capanne rotonde costruite a nord del golfo e quelli dell’omonima fortezza a sei miglia nell’interno, che accoglieva le carovane egiziane, si guadagnavano da vivere vendendo acqua e provviste ai pellegrini. Nel bazar che veniva sommerso tutti i giorni dall’alta marea, ci siamo riforniti di carne, riso e pane. Io ho anche trovato un droghiere che mi ha venduto un’oncia di oppio a un prezzo ‘cinese’.
Nel grande caffè che sorgeva vicino alla spiaggia i posti all’ombra erano tutti occupati da un gruppo di Persiani sbarcati prima di noi, intenti a pulirsi i denti con il coltello, perciò ci siamo sistemati all’interno. Il rustico edificio consisteva in una tettoia sorretta da tronchi di dattero rozzamente tagliati con tracce di muro che lasciavano ampio spazio al passaggio della luce. Tutt’intorno al locale c’era un sedile di terra battuta coperto di mattoni, che fungeva da divano su cui appoggiare i tappeti per sedersi e dormire. Al centro c’era una piattaforma quadrata con la stessa funzione e un ripiano di argilla, un kawaji, sotto cui mettere il carbone, che sorreggeva tre grosse caffettiere imbrattate di macchie. Vicino ad esse erano allineati alcuni narghilé egiziani, i shishas, luridi e consunti. Una struttura in legno bucherellato reggeva gli orci di terracotta, i gullah, pieni d’acqua fresca e dolce, in vendita a cinque paras l’uno. La bottega del caffè era simile a tutte quelle che si trovano fra Alessandria e Aden e mescolava in parti uguali fumo, vapore, mosche e moscerini, ma la sua atmosfera tranquilla compensava le sgradevolezze e la scarsezza di arredamento.
In questo locale il mio travestimento ha corso il rischio di essere scoperto. Fra gli individui che bighellonavano nel caffè fumando, bevendo e pulendosi i denti col pugnale, ce n’era uno che mi era sempre accanto e faceva domande, ficcando il naso nelle mie faccende. Si definiva un Pathan, parlava cinque o sei lingue, conosceva gente dappertutto e aveva viaggiato in lungo e in largo in Asia centrale. Quando mi ha chiesto dove fossi nato, gli ho risposto che da quando ero diventato un derviscio, avevo rinunciato al mio nome e alla mia nazionalità. Ma poiché lui insisteva, io l’ho esortato a indovinare e, con mia grande gioia, il mio invito lo ha indotto a proclamarmi suo fratello Pathan. Dopo questo riconoscimento ci siamo seduti a fumare, mentre scambiavamo amichevoli effusioni.
Il 14 luglio abbiamo lasciato al-Wijh alle otto di mattina, dopo aver passato una notte abbastanza confortevole al caffè. Il comandante aveva promesso di raggiungere Jabal Hassani in giornata, ma i viaggiatori non gli avevano creduto e avevano fatto provviste. Abbiamo navigato fra sporgenze di roccia, sabbie dorate, canneti verdeggianti e una linea gialla che da lontano sembrava schiuma lasciata dalla tempesta. Dalla cima dell’albero maestro un marinaio osservava l’acqua azzurra e trasparente come vetro e gridava la direzione da seguire, ma lo strepito dei passeggeri sovrastava la sua voce e rendeva vana la precauzione. Tuttavia, facendo virare la nave e cambiando direzione al momento opportuno, il capitano ha evitato le secche. Verso mezzogiorno siamo passati davanti all’isola su cui sorgeva la tomba bianca e a forma di cupola dello sceicco Hasan al- Marabit, circondata dalle casupole dei guardiani. Passando davanti all’isola, piatta, gialla, rocciosa e desolata, i peccatori vivi recitavano una preghiera e una fatihah per l’anima del defunto, poi riprendevano il cammino con rinnovato fervore religioso.
Al tramonto abbiamo gettato l’ancora vicino a una delle barriere coralline del Mar Rosso, enfaticamente ma meritatamente descritte da Forksal come luxus lususque naturae. Da lontano, le sue cavità color ametista piene d’acqua sembravano fiori dai colori brillanti. I gabbiani e le sterne si appoggiavano sul corallo per divorare la preda, mentre stormi di altri uccelli si contendevano rumorosamente un esoceto e un branco di pesci in fuga solcava velocemente la superficie dell’acqua provocando spruzzi schiumosi. Al calar della notte, la scena rivelava nuove bellezze. Il profilo indistinto del paesaggio, avvolto dalle ombre, lasciava spazio all’immaginazione, mentre il mare brillava di luce metallica sotto ai raggi della luna. I lampi fosforescenti dell’acqua contro i coralli, che gli Arabi chiamano ‘gioielli degli abissi’, trasformavano il sito in un luogo d’incanto, una terra dove le ninfe e le divinità marine venivano a trastullarsi e non sarebbe stato sorprendente udire il vecchio Proteo chiamare il gregge con la sua conchiglia contorta o vedere Afrodite adagiata nella sua conchiglia.
Ma, come ha filosoficamente osservato Sir Cauline il Cavaliere:
Ogni candore contiene nerezza, Ogni dolcezza ha un sapore amaro.
e l’incantevole barriera corallina ha rischiato di causarci un brutto incidente. Il vento che soffiava dal mare ci spingeva lentamente contro di essa e l’ancora non riusciva a tenere il battello ormeggiato perché il cavo troppo corto non raggiungeva il fondale. Come le navi mercantili inglesi di un tempo, il Filo d’Oro difettava di misure di sicurezza. Se la nostra imbarcazione fosse finita contro il corallo tagliente sarebbe scomparsa a poco a poco in mare, come una prugna nello sciroppo, perciò abbiamo cominciato a fare rumore per attirare l’attenzione. Il comandante della nave dei Persiani, indovinando la causa dei nostri affanni, ha mandato in soccorso due marinai con una fune e pochi minuti dopo eravamo saldamente ancorati alla poppa dell’imbarcazione dei nostri servizievoli vicini.
Siamo ripartiti all’alba del 15 luglio. Verso mezzogiorno abbiamo oltrepassato Jabal Hassani e un’ora prima del tramonto siamo giunti nella baia di Marsa Mahar, i cui bordi erano scoscesi. In alcuni punti la superficie erosa e irregolare delle rocce calcaree presentava delle sporgenze a forma di tetto, in altri il vento e la pioggia avevano scavato delle caverne. Nell’azzurra lontananza una zona selvaggia di boschetti di palme rallegrava gli occhi alla ricerca di qualcosa di verde.
Mentre raggiungevamo la riva, le rocce aguzze ci hanno tagliato la pelle dei piedi. Ho sentito qualcosa penetrare in un dito e ho esaminato la parte. Dopo aver estratto una specie di spina, non ci ho più pensato. Non immaginavo neanche lontanamente i problemi che mi avrebbe causato in seguito. In cima alle rocce su cui ci siamo arrampicati, abbiamo incontrato alcuni Arabi seminudi sdraiati all'ombra. Erano disarmati, ma con un’espressione tale da spaventare i più timidi. Essi vivevano nelle caverne ed erano ittiofagi, perciò non avevano datteri, carne o latte da darci. Ci hanno invece venduto dei pesci che in India chiamano ‘Bui’ e che sono deliziosi cotti alla brace. Dopo aver mangiato, bevuto e fumato abbiamo cominciato a sentirci più allegri.
La pigrizia del nostro comandante ha fatto sì che non arrivassimo a Yanbu neanche il giorno dopo, anche se eravamo già in vista della nostra destinazione finale. Scorgevamo anche la cima del Jabal Radhwa, una delle Montagne del Paradiso, celebrate in poesia e nelle devozioni, che riforniva Medina di cote per affilare.
Abbiamo sistemato il giaciglio sulla spiaggia e abbiamo cominciato a preparare la cena. La scarsità d’acqua, unita ad altre difficoltà, ci rendeva tutti scontrosi come orsi. Ci siamo alzati prima dell’alba, decisi a costringere il comandante a partire. C’era solo una striscia di terra a dividerci dal porto di arrivo, ma la mancanza di vento, i massi e le secche ci hanno costretti a fare un détour. A mezzogiorno, stavamo ancora bordeggiando lungo la piccola baia che conduce al porto di Yanbu, per raggiungere il quale abbiamo dovuto trasbordare in un battello da spiaggia. Nel dire addio all’ignobile Filo d’Oro ci siamo sentiti risollevati. Erano passati dodici giorni dalla nostra partenza da Suez.
Il sole, la rugiada e l’acqua del mare avevano rovinato il mio piede ferito e, anche se riuscivo a malapena ad appoggiarlo in terra, i miei doveri di viaggiatore mi imponevano di visitare la città. Mi sono messo in cammino sostenuto dal mio servitore, mentre lo sceicco Hamid e il resto del gruppo si recavano alla dogana.
Yanbu al-Bahr o Fontana del Mare, identificata da Bruce come la Iambia di Tolomeo, è un porto di grande importanza, che divide con altri il titolo di ‘Porta della Città Santa’. E’ il porto di Medina come Gedda lo è della Mecca. Molti pellegrini lasciavano nei suoi magazzini le merci più preziose o pesanti, che non potevano portare con sé. Una parte del grano, dei datteri, dello henna e di altre merci in transito proveniva dalla costa occidentale del Mar Rosso.
Qui finiva l’autorità del pascià d’Egitto e cominciava quella del Sultano. Il governatore della città era un capo arabo, uno sharif. L’ho incontrato al bazar: era un bell’uomo giovane, con la carnagione chiara e un profilo nobile, era ben vestito e portava un turbante di cachemire. Era armato di spada e di daga ed era seguito da due alti schiavi neri dallo sguardo fiero, che si appoggiavano a due enormi bastoni, i nabbut. Non si vedevano in giro i soldati dell’esercito regolare, i nizam.
La città non aveva nulla di straordinario. Sorgeva all’estremità settentrionale di una insenatura stretta e ventosa ed era formata da una lunga linea di edifici di un bianco abbagliante, che si stagliavano contro il cielo color cobalto e il mare color indigo, mentre i colori della pianura, sul cui sfondo si ergeva il lugubre monte Radwah, andavano dal marrone chiaro al color bronzo
“Barren and bare, unsightly, unadorned.”
“Arido, brullo, laido e disadorno.’
All’esterno delle mura vi erano alcune tombe e cupole, che non meritavano attenzione. All’interno delle mura le case di pietra calcarea e corallina sorgevano lontane le une dalle altre, salvo che nella zona del porto. Le finestre erano enormi e i muri, pieni di fossili, si sbriciolavano come un dolce di mandorle. A paragone degli edifici dei quartieri musulmani del Cairo, queste costruzioni apparivano miserabili. La via del mercato, il suk, consisteva, come tutte, in una via lunga e stretta ombreggiata da foglie di palma. Vi erano piccoli negozi e numerosi caffè, pieni della sporcizia dei viaggiatori, dove era impossibile riposare senza un ventaglio per scacciare le mosche. Gli ufficiali turchi della dogana situata davanti al punto di sbarco, vestiti con il tarbush, passavano le giornate a dormire sui divani vicino alle finestre.
Non si prendevano il disturbo di esaminare il contenuto dei bagagli, si limitavano a chiedere tre piastre a tutti. In una baracca coperta di foglie di dattero c’era un hammam gestito da un vecchio turco, che si guadagnava da vivere tirando a lucido i viaggiatori. Fra gli edifici pubblici della città vi erano alcune moschee e minareti di semplice architettura, un wakalah o due per alloggiare i mercanti e la tomba di un santo.
L’acqua potabile era motivo di vanto rispetto alle altre città dell’Hijaz. Dentro ad alcune cisterne poste sulle colline veniva raccolta l’acqua piovana, che era poi trasportata in città a dorso di cammello e messa a disposizione di chi poteva permettersi di comprarla. Alcune persone anziane tuttavia, per abitudine, preferivano bere l’acqua salmastra dei pozzi. Di loro si diceva che, quando andavano al Cairo, salavano l’acqua del Nilo per renderla più gradevole.
Il viaggiatore appena arrivato rimaneva abbastanza sorpreso dal fanatismo e dalla litigiosità degli abitanti. Per sottolineare il proprio rango e seguire la moda, che anche nel deserto esercita la sua tirannia, gli sceicchi e i gentiluomini andavano vestiti e armati in modo eccessivo. Per non parlare dei soldati irregolari, che portavano a spasso un vero arsenale. Anche i beduini, torvi, sporchi e orgogliosi, erano armati fino ai denti. Persino la parte più pacifica della popolazione non usciva mai di casa senza un nabbut, un randello. Più l’arma era grossa e pesante, maggiore era il coraggio vantato dal suo portatore, che la usava con pericolosa abilità per risolvere le liti. Le donne si vestivano come le Egiziane, ma portavano un velo bianco sul viso. Arrivando dall’Egitto, non si poteva fare a meno di notare che gli abitanti avevano un aspetto sano e che i bambini non erano affetti da oftalmia, come accadeva invece nella valle del Nilo.
I miei compagni di viaggio mi hanno raggiunto in un caffè, dove mi ero seduto per riposarmi dalla fatica di trascinare in giro il mio piede ferito. Avevano prenotato una stanza ben aerata in un wakalah di fronte al bazar, un po’ meno infestata delle altre dalle mosche e con una terrazza di fronte al mare.
Verso sera, abbiamo fatto venire un agente, un mukharrij, per noleggiare i cammelli, e un uomo di Medina si è offerto di fare da intermediario. L’agente si è battuto energicamente per non rinunciare anche a pochi centesimi, ma noi non siamo stati da meno. La contrattazione è stata lunga, ma alla fine ci siamo intesi e l’affare si è concluso. Ogni bestia da soma ci costava tre dollari, metà dei quali subito e l’altra metà all’arrivo. Saremmo partiti la sera del giorno dopo, insieme a una carovana che trasportava grano, scortata dalla cavalleria irregolare. Ho posto come condizione che i miei due animali fossero rimpiazzati se avessi dovuto abbandonarli per strada. Quando il mujarrij ha detto che la tribù Hazimi era sul piede di guerra e che avremmo potuto essere attaccati, lo sceicco Nur ha suggerito di aspettare che le acque si fossero calmate. Le sue parole hanno avuto un cattivo influsso su Mohammed e lo hanno fatto cambiare in peggio. Non ho potuto fare a meno di dirgli: “Come! Tu che al Cairo eri coraggioso come un leone, ora sei diventato uno spregevole codardo!”
Il caldo e il vento del deserto sembravano avere effetto persino sui miei compagni di viaggio. Dopo aver trascorso il pomeriggio nella nostra stanza, abbiamo cenato sulla terrazza dove, fra padroni, servitori, stranieri e bambini, eravamo almeno una ventina di persone, tutte sedute su stracci e cuscini attorno a un unico calderone contenente montone e riso bollito cosparsi di burro chiarificato. Abbiamo conversato fino alle dieci, che a queste latitudini è considerata un’ora tarda, fumando e bevendo caffè. Dopo aver recitato lo isha, il vespro, abbiamo disteso i nostri materassi sulla terrazza e ci siamo messi a dormire.
La mattina del 16 luglio abbiamo acquistato le provviste per il viaggio, preparato i bagagli, pulito e caricato le armi e indossato abiti adatti. Io mi sono vestito da arabo, per non pagare la jiziat, la tassa che le tribù del deserto esigono dai viaggiatori stranieri. Ho comprato anche uno shugduf, una lettiga, di solito usata dalle donne e dai bambini, da sistemare sul cammello. La ragione per cui me ne servivo era che al suo interno mi era più facile scrivere. Tuttavia, per non sminuire la mia virilità, ho trovato la scusa del piede ferito, anche se prima di entrare in un centro abitato affittavo o prendevo a prestito un animale sellato.
Subito dopo il pranzo, consumato in anticipo, abbiamo cominciato a caricare i cammelli, che erano già in attesa vicino alla porta sin da mezzogiorno. I loro proprietari protestavano a gran voce per il peso eccessivo delle merci, mentre i commercianti che ce le avevano vendute giuravano che anche un bambino era in grado di portare quel carico. Le bestie erano schierate dalla parte dei proprietari e gridavano da far pietà, cercando di mordere. Alla fine, si sono alzate di colpo e hanno fatto cadere tutti i sacchi e le scatole della soma. Alle tre del pomeriggio eravamo pronti per partire, i cammelli erano tutti allineati in fila indiana, ma proprio allora gli uomini si sono dispersi in tutte le direzioni e abbiamo dovuto rimandare la partenza al tardo pomeriggio.
Il costume da viaggio di uno sceicco arabo, ormai quasi abbandonato, è quanto di più pittoresco si possa immaginare. La testa, rasata o adorna di lunghi riccioli, è coperta da uno zucchetto bianco, sul quale è avvolta la kufiah, il tessuto rosso di seta o di cotone con il bordo giallo, piegato a triangolo, dal quale pendono fili e nappe lunghi fino alla cintola. Il foulard è tenuto fermo dall’aakal, un nastro di corda o una treccia di lana ritorta, e sporge sul davanti, ombreggiando gli occhi e dando al volto un’espressione fiera. A volte una delle sue estremità è annodata dietro al capo, dopo essere stata fatta passare sotto al mento. Prima di entrare in combattimento, un capo adotta il lisam, la velatura dei propri lineamenti, che è anche il travestimento abituale di chi teme una vendetta o della donna che prende il suo thar, il diritto alla vendetta. Quando fa caldo, la velatura protegge dal simun, quando fa freddo, protegge i polmoni dal catarro. Il vestito consiste in un kamis, una lunga tunica di cotone con le maniche strette, aperta sul davanti e ornata attorno al collo da ricami a forma di rete, che vanno fino ai piedi. I beduini considerano effeminati i pantaloni larghi indossati da alcuni e nessuno è ancora arrivato alla follia di portare calze e calzini. Sul kamis si getta un ampio mantello di peli di cammello, con le maniche corte, chiamato aba, che può avere diverse fogge e colori. Può anche essere fatto di materiali differenti, che vanno dalla seta alla più rozza lana di pecora. Il colore preferito in Al-Hijiaz è il bianco, con ricami dorati, fili d’argento o gialli che formano due grandi triangoli, coronati da strisce e decorazioni che salgono verso le spalle e scendono lungo la schiena. L’interno, all’altezza delle spalle e del petto, è foderato di seta o di cotone ed è legato davanti con nastri elaborati che hanno all’estremità delle nappe e delle ghiande di seta e d’oro. Alla fusciacca che tiene il kamis fermo in vita è appeso il pugnale ricurvo con l’impugnatura d’argento, il jambiyah, La calzatura che completa questo abbigliamento è il tipico sandalo arabo. Gli sceicchi portano sulla schiena una spada e un archibugio e nella mano destra hanno un corto giavellotto o un bastone ricurvo di due piedi e mezzo, chiamato mas’hab, che usano per guidare i cammelli.
Gli appartenenti ai clan più poveri si avvolgono in vita, a contatto con la pelle, una lunga treccia di cuoio grasso, per sorreggere la schiena e legano la camicia con una corda o con una rozza fascia, nella quale è infilato il pugnale. In una bandoliera gettata sulle spalle portano la cartucciera, il sacchetto con la polvere, la pietra focaia, l’acciarino, l’innesco e altre cose necessarie. Il punto vita del viaggiatore è una parte del corpo piuttosto sovraccarica. Sotto alla sciarpa e alla cintura di cuoio c’è il sacchetto dei soldi, nascosto dalla tunica, che è sempre guarnita da un paio di pistole a canna lunga con l’impugnatura d’argento, da un piccolo pugnale, da un calcatoio con tenaglie all’interno, dal sacchetto per le cartucce e lo stoppaccio e da una fiaschetta per la polvere da sparo. La spada è appesa alla spalla con delle corde di seta color cremisi ornate con grossi fiocchi; gli uomini eleganti adornano in questo modo anche le loro pistole. In mano, un archibugio con l’imboccatura a campana o, meglio ancora, un fucile a una canna con un calibro di un pollice. Tutte queste armi devono brillare come argento, se si vuole essere rispettati, perché la cura cavalleresca delle armi è un segno di virilità.
Per sottolineare la sacralità del viaggio, i pellegrini, specialmente quelli provenienti dalla Turchia, portavano attaccata a un cordoncino di seta appeso alla spalla sinistra una bella scatola rossa di pelle o di velluto ricamato, che conteneva un hamail, un Corano tascabile,
Nella mia scatola, suddivisa in tre scompartimenti, al posto del Corano avevo messo l’orologio, la bussola, un po’ di denaro, una matita, un temperino e alcuni piccoli fogli di carta per scrivere e disegnare. L’abitudine degli Europei di prendere appunti è una cosa che sconcerta i beduini e scatena la loro immaginazione. Per questo ci si può aspettare il peggio e il viaggiatore deve stare attento a scrivere e a disegnare davanti a loro, perché potrebbe essere scambiato per una spia o per uno stregone.
Abbiamo lasciato il wakalah alle sei del pomeriggio. I cammelli, per l’impazienza, grattavano il terreno con gli zoccoli. Il mio shugduf era issato su di un animale alto e forte e il cammelliere mi ha detto di raggiungerlo arrampicandomi sul collo dell’animale, ma il mio piede ferito mi impediva di fare questo movimento, perciò ho insistito perché l’animale venisse fatto accovacciare.
I fratelli di Omar Effendi hanno insistito per accompagnarci alle porte della città per accomiatarsi. Al momento della partenza, il gruppo si è nuovamente disperso: chi è andato al caffè, chi al porto, chi a comprare una cosa dimenticata. Era il tramonto quando, dopo la preghiera, ci siamo avviati lungo le strade strette e polverose, fiancheggiate da abitazioni imbiancate a calce e da mucchi di immondizia, fra grida di “Wassit, ya hù!”(Vai al centro della strada!) e “Jannib, y’al jammal!” (Tieniti ai lati, cammelliere). Quando siamo emersi dall’ombra delle case siamo stati inondati dalla luce abbagliante della luna. L’aria dolce del Deserto contrastava con quella sgradevole della città. I miei compagni di viaggio, come sempre in queste occasioni, si sono messi a cantare.