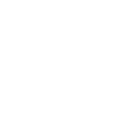DA LONDRA A SUEZ
La sera del 3 aprile 1853 ho lasciato Londra per Southampton e la mattina seguente, travestito da principe persiano, mi sono imbarcato di buon’ora sul vaporetto a elica Bengala. Ho passato le due settimane successive a impratichirmi nelle maniere e nei comportamenti orientali.
La traversata, lunga ma non troppo, è stata tranquilla e monotona, senza nulla di cui lamentarsi. Il battello era confortevole e il cuoco, strano a dirsi, bravo. La sera del tredicesimo giorno di navigazione, il pilota ha finalmente fatto la sua apparizione sul ponte e il Bengala ha gettato l’ancora davanti a Punta Argilla.
Sono sbarcato in compagnia del caro amico John W. Larking, che mi aveva invitato a casa sua, per cominciare da lì il mio viaggio. Mi sono rallegrato nel constatare che, senza la barba e con la testa rasata, riuscivo a ‘sottrarmi all’attenzione inquisitiva dei locali.’ I curiosi davanti ai quali siamo sfilati, quando mi sentivano dire “Alhamdolillah”, sussurravano “Musulmano!” La popolazione infantile mi ha così risparmiato i complimenti che di solito vengono riservati alle teste incappellate. Un bambino, considerando l’occasione propizia a un atto di generosità da parte mia, mi ha guardato dritto in faccia ed ha esclamato: “Bakshish!”, ma ha ottenuto per tutta risposta un “Mafish!”, che ha convinto gli astanti che la mia pelle di pecora ricopriva una vera pecora. Siamo saliti su di un carro, ci siamo fatti strada fra gli asini e mezz’ora dopo eravamo seduti a casa del mio amico Larking, con una tazza di caffè in mano e il chibùk fra le labbra.
Che meraviglioso contrasto fra la vita sul battello e quella nella villa affacciata sul canale Mahmudiyah! Era come passare, all’improvviso, da un ritmo musicale veloce a uno lento. In tredici giorni avevo lasciato alle spalle la pesante nebbia grigia e l’atmosfera creata dalle industrie attorno all’isola di Wight dove era ancorato il battello, avevo attraversato il Mediterraneo, con la sua piacevole brezza e la bruma leggera e scintillante, con i colori azzurro e porpora del vecchio e incantevole profilo nordafricano, per venire di nuovo ad ascoltare, restando silenzioso e immobile, la melodia sempiterna dell’Oriente, il debole vento notturno dal suono pieno di significati malinconici che erra fra il cielo pieno di stelle e i ciuffi d’erba dei prati.
In Asia le fantasticherie hanno uno spazio più rilevante che in Europa, dove ha più valore la vita concreta. In Oriente il kaif, il sapore di un’esistenza puramente animale, il godimento passivo dei sensi, il piacevole languore e la tranquillità sognante, risultato di una natura vivace, impressionabile, eccitabile e di una squisita sensibilità dei nervi, permette una voluttà sconosciuta nei nostri paesi, che fanno consistere la felicità nell’esercizio delle proprie capacità mentali e fisiche. In Occidente, dove Ernst ist das Leben, dove la terra avara costringe a un sudore incessante e l’aria umida e fredda richiede movimento, l’uomo è alla ricerca perenne di qualcosa di meglio attraverso l’esercizio, il cambiamento, l’avventura e la dissipazione di energie. L’uomo orientale invece non cerca altro che ombra e riposo. Lungo le rive di un ruscello gorgogliante o al fresco riparo di un albero profumato, egli fuma la pipa, sorseggia una tazza di caffè, beve un sorbetto, lascia il più possibile tranquilli il corpo e la mente ed è perfettamente felice. La conversazione fastidiosa, i ricordi spiacevoli, i pensieri vani rappresentano delle interruzioni sgradevoli del kaif, parola che non ha corrispondente nella lingua inglese.
Ad Alessandria, ho abbandonato il mio travestimento da principe persiano a favore di quello di un medico orientale. Gli abitanti della città guardavano le mie fiale e le scatole di pillole con il desiderio di conoscerne il contenuto. Anche il personaggio che rappresentavo, un dottore indiano, un po’ mago, un po’ fachiro, venuto da lontano per esercitare la ‘grande medicina’, era una novità per loro. Uomini, donne e bambini si affollavano in gran numero alla mia porta e io potevo vedere in viso anche le donne, di cui gli europei conoscono solo gli esemplari peggiori. I nativi più rispettabili, dopo aver assistito alla mia esecuzione di un mandala e alla rappresentazione dello specchio magico, mi credevano un sant’uomo, dotato di poteri soprannaturali e depositario di ogni sapere. Un vecchio mi ha persino offerto in sposa la figlia e una donna di mezz’età voleva darmi cento piastre perché restassi a curarle l’occhio sinistro cieco.
Il lettore non deve pensare che mi comportassi da ‘carabin’ o da ‘sangrado’, senza conoscere nulla di medicina. In realtà, da giovane avevo fatto studi medici e mistici e mi consideravo qualificato come se avessi preso un diploma buono per l’estero a Padova.
Dopo un mese ho deciso di cambiare il mio titolo da Mirza a Sheik e mi sono preparato ad assumere le sembianze di un derviscio itinerante, sotto la guida di un uomo religioso, che mi ha iniziato al suo ordine con il titolo pomposo di Bismilla-cha, Re nel nome di Dio. Divenendo derviscio, io dovevo rinunciare alle mie occupazioni terrestri e al mio nome laico. Dopo un periodo di prova sono stato elevato al rango di Mushid, una specie di capo, con il diritto di avere allievi e seguaci.
Nel mondo musulmano, il ruolo di derviscio permette di dissimulare la propria identità e per questo è assunto da persone di ogni rango, età e confessione, dal grande signore che ha lasciato la corte al contadino che è troppo pigro per lavorare la terra, dal ricco annoiato al mendicante che chiede un pezzo di pane di porta in porta. Il derviscio è un vagabondo privilegiato, autorizzato a ignorare la gentilezza e il saper vivere perché non appartiene più a questo mondo. Egli può pregare o non pregare, sposarsi o restare celibe, ma sarà sempre rispettato sia che porti il saio sia che si copra d’oro, può spostarsi a piedi o sulla sua giumenta araba, da solo o con una dozzina di servitori, nessuno gli chiederà mai che cosa stia facendo o dove stia andando. Anche se è disarmato, lo si teme come se camminasse per strada armato fino ai denti. Inoltre, il suo atteggiamento altero e sdegnoso verso il popolo è fonte di rispetto e questo rappresentava un vantaggio notevole per un viaggiatore straniero de caractère come me. E poiché in Oriente il folle - come in Occidente l’eccentrico - può fare e dire tutto quello che vuole, il derviscio non ha che da simulare la propria pazzia improvvisa e la salvezza è assicurata. Se possedete qualche nozione di medicina e qualche capacità di mago, se avete fama di non interessarvi ad altro che agli studi e ai libri, se avete delle risorse sufficienti per non morire di fame, in Oriente voi fate una bella figura. Il solo pericolo di questa ‘via mistica’ è che, a volte, gli stracci del derviscio nascondono un volgare bandito, la cui compagnia potrebbe costarvi il bastone se non addirittura la vita.
L’idiosincrasia del vagabondo di razza è una combinazione in uguali proporzioni di quello che i frenologi chiamano ‘attaccamento a un luogo’ e tendenza al cambiamento. Dopo una marcia lunga e faticosa, il giramondo stramazza nel più vicino luogo di riposo e si trasforma nel più domestico degli uomini. Per un po’ egli fuma con entusiasmo la pipa della permanenza, fa la siesta più volte al giorno, di notte dorme come un ghiro, prova piacere a cenare alla stessa ora e si stupisce di chi non trova eccitanti i pettegolezzi, le conversazioni, i giornali e i libri. Ma questo istinto sedentario non dura a lungo e viene ben presto sopraffatto da un’ondata di noia. Il viator comincia a perdere l’appetito, di notte cammina per la stanza, sbadiglia nelle conversazioni e si assopisce davanti a un libro. Vuole andarsene e, per non morire, deve farlo in fretta.
Ad Alessandria avevo passato un mese piacevole, ma percepivo l’arrivo del nemico, a cui mi sono arreso, dato che nulla si opponeva alla mia partenza. Tuttavia, mi restavano ancora molte cose da fare. Avevo lasciato l’Inghilterra senza passaporto, una negligenza che avrebbe potuto costarmi cara senza l’aiuto del mio amico Larking. Il console, da cui mi ero recato con abiti sporchi e facendo uso di un cattivo inglese, mi aveva rilasciato con qualche difficoltà un certificato, che mi era costato un dollaro. Il documento attestava che ero un soggetto indo-britannico di trent’anni di nome Abdullah, di professione medico, senza segni particolari. Per poter viaggiare in Egitto con un pugnale e delle pistole ho trascorso diversi giorni nei vari uffici in attesa di un visto, secondo l’uso orientale.
Il mio nécéssaire da viaggio era costituito da un sacco consunto contenente un bastoncino per i denti, un miswak, un pezzo di sapone e un pettine di legno. Il mio guardaroba era altrettanto essenziale e consisteva in un cambio o due di vestiti. Chi viaggia in Oriente deve tenere presente che è importante avere almeno un vestito elegante per le grandi occasioni per non essere considerato povero, dato che i poveri qui, come in Occidente, se non appartengono a un ordine religioso che prescriva la povertà, sono trattati come furfanti. La mia borraccia era una zemzemiah di pelle di capra, che dava all’acqua un aspetto ferruginoso e un sapore disgustoso di tannino. Tuttavia era necessaria, perché se avessi bevuto in un bicchiere contaminato da un consumatore di carne di maiale avrei perso la reputazione.
Avevo un tappeto persiano di poco prezzo che mi serviva da letto, da sedia, da tavolo e per le prostrazioni; un cuscino di chintz; una coperta; un lenzuolo, che funzionava anche da tenda e da zanzariera nelle notti calde. Possedevo un grande ombrello giallo di fattura orientale, che somigliava a una calendula gigante e che mi garantiva l’ombra anche quando non c’era. Mi ero portato un astuccio da lavoro di canapa, con aghi, filo, forbici, bottoni e pece da calzolaio, che mi aveva regalato una mia cara parente, Miss Elisabeth Stisted, e che era molto utile in un paese dove i sarti sono rari. Portavo indosso un pugnale, un calamaio in ottone, un’asticciola per i pennini e un rosario di grandi dimensioni, da usare come arma in caso di pericolo. Tenevo le monete d’argento e il denaro spicciolo in un borsellino di cotone infilato in una tasca sul petto, non essendo possibile in questi paesi trasportarli in una scatola o in valigia. Conservavo invece le sovrane/sterline d’oro e i documenti in una cintura di cuoio, di manifattura magrebina, allacciata in vita sotto al vestito, secondo il sistema asiatico. Ma questa cintura, oltre a non essere molto sicura, era pesante, specialmente quando conteneva dei dollari e causava irritazione e disagio di notte.
Il mio guardaroba era sistemato in due bisacce da sella, i khurjìn; il letto poteva essere facilmente arrotolato e legato; una scatola color verde chiaro con fiori rossi e gialli, abbastanza robusta da sopportare almeno due cadute al giorno, conteneva i medicinali.
A fine maggio tutto era pronto. Lasciavo con rimpianto la mia piccola stanza fra i fiori bianchi del mirto e quelli rosa dell’oleandro dal profumo di mandorle, ma era giunto il momento di accomiatarmi dal mio ospite e di dire addio ai miei cinquanta pazienti. Sono salito su di un minuscolo carretto, tirato da un mulo recalcitrante, che scalciava e mordeva, e mi sono diretto al molo per salire a bordo del ‘Piccolo Battello Asmatico’, che era in partenza.
Ci insabbiavamo tre o quattro volte al giorno, con penosa regolarità, nell’acqua bassa dello sporco e monotono canale Mahmudiyah e, invece delle consuete trenta ore, ci sono voluti tre giorni e tre notti per arrivare al Cairo. Intorno a noi vedevamo solo acqua fangosa e sponde polverose. L’aria, rovente come quella che esce dalla fornace di un vasaio, era piena di granelli di sabbia, il cielo era lattiginoso, il sole abbagliante e, sullo sfondo, le piramidi di Khufa e Khafra alzavano ‘le loro punte maestose sopra al margine del deserto’. Quando abbiamo attraccato di fronte al vecchio e fatiscente sobborgo di ‘Bulak’ il sollievo era grande.
Il paesaggio mi ricordava quello del Sind ed era doppiamente monotono. C’era la stessa foschia mattutina, lo stesso bagliore accecante del mezzogiorno, lo stesso vento torrido, le stesse nuvole di caldo afoso e soffocante. Erano gli stessi anche il tramonto fiammeggiante, la luce della sera, le colonne di polvere dette ‘diavoli di sabbia’ che spazzavano la pianura come giganti, l’acqua torbida e poco profonda dei fiumiciattoli costellati di isolotti di limo, le rovine in cima alle scarpate dalla base erosa, le sponde coperte di granelli lucenti di terra salina, le capanne solitarie, le colombaie e i ragazzi che tiravano pietre agli uccelli, le palme, le tamerici, le mimose, il mais, il tabacco e le canne da zucchero che formavano delle macchie di verde, le imbarcazioni a vela latina, i contadini dalla pelle scura e le tuniche azzurre, che dormivano all’ombra o dietro l’aratro, lo stesso dai tempi di Osiride, i cammelli macilenti e infestati dalla rogna, i bufali coperti di fango, gli asini con lo scorbuto, gli sciacalli striscianti, i cani simili a volpi, gli aironi, i pellicani, le gru, i nibbi e le gallinelle d’acqua.
Il mio biglietto di terza classe corrispondeva a un posto sul ponte superiore, una sistemazione che acuiva le miserie del viaggio. Di giorno, il sole filtrava attraverso la tenda come acqua bollente, di notte, la rugiada avvolgeva l’abitacolo come fredda bruma scozzese. Il cibo era disgustoso, ma un derviscio non poteva sedersi a tavola con gli infedeli e mangiare alimenti contaminati, perciò sedevo in disparte a fumare, a pregare e a sgranare il grosso rosario. Bevevo dalla borraccia l’acqua fangosa del canale e masticavo pane e aglio, simulando una devozione perfetta.
Sul piccolo e sovraccarico battello a vapore, soprannominato l’Asmatico, regnava il più grande disordine, perché i posti non erano stati assegnati. Fra le persone a bordo, c’erano: due ufficiali dell’Indian Army, che parlavano solo fra di loro, bevevano cattivo tè e fumavano i propri sigari; una compagnia di kawas, soldati irregolari curdi, che scortavano un tesoro; un gruppo di Greci rumorosi, che facevano battute grossolane sgradite ad alcuni severi musulmani lì vicino; alcuni Italiani taciturni, burberi e compassati, accompagnati da interpreti chiassosi, incaricati di acquistare dei cavalli per conto di Sua Maestà il Re di Sardegna, che, con abilità machiavellica, riuscivano a sottrarsi alle domande insistenti di un gruppo di commercianti francesi di ritorno dal Cairo; un Tedesco che era pieno di birra come un boccale dal mattino alla sera; un mercante siriano, l’uomo più ricco e brutto di Alessandria. La sola donna graziosa a bordo era una ragazza spagnola, che appariva fuori posto quanto una rosa in un campo di cardi. Francesi erano anche alcuni imbianchini, diretti a Shubrà a dipingere il palazzo del pascià, veri figli di Parigi, montagnardi, volterriani e spensierati. Sedevano tutto il giorno in coperta chiacchierando vivacemente, come solo loro sanno fare, e citando proverbi gallici del tipo on ne viellit jamais à table. Giocavano a écarté per amore del gioco, si preparavano des ponches un peu chiques, raccontavano avventure mirabolanti, cantavano, ballavano, dormivano e si svegliavano per ricominciare a bere, giocare, parlare, ballare e cantare.
Uno di loro intonava:
“Je n’ai pas connu mon père
Ce respectable vieillard.
Je suis né trois ans trop tard.”
(Traduzione: “Non ho mai conosciuto mio padre, quel rispettabile vecchio.
Sono nato tre anni troppo tardi.”)
Un altro rispondeva a gran voce:
“Qu’est ce que je vois?
Un canard en robe de chambre!”
(Traduzione: “Cosa vedo? Un’anatra in vestaglia!”)
Erano dei neofiti, ancora lontani dall’umore funereo che spesso prende gli Europei che viaggiano in Oriente. Mi hanno offerto da bere una bevanda forte e sono stati gentili nei miei confronti, a differenza di altri passeggeri con cui sono stato meno fortunato. Un negoziante corpulento ha minacciato di briser ma figure perché avevo avvicinato la pipa ai suoi pantaloni, ma vedendomi accarezzare l’impugnatura del pugnale mentre lasciavo l’oggetto al suo posto, ha dimenticato la sua minaccia. Uno degli ufficiali inglesi, a cui avevo sfiorato il gomito, ha mormorato sottovoce che non ci dovevo vedere bene. Egli prestava servizio nel mio stesso corpo e la sua affermazione era un complimento involontario al mio travestimento e per questo l’ho perdonato.
In Egitto il caravanserraglio è chiamato wakalah ed è formato da un blocco di edifici costruiti attorno a un cortile quadrato, che fungono da albergo e da deposito. I locali adibiti a magazzino, simili a caverne, sono al piano terra, accanto alle botteghe del sarto, del calzolaio, del panettiere, del tabaccaio e del fruttivendolo. Gli appartamenti, invece, formati da due o tre stanze con un focolare per cucinare e una tinozza per fare il bagno, sono al primo piano e si affacciano su di una galleria, a volte coperta, a volte scoperta. Alcuni caravanserragli hanno anche un secondo piano, spesso esposto ai venti e al sole. Le scale sono strette, ripide, sporche, buie e malandate. Sui pianerottoli sono impastoiati degli asini e delle capre e qua e là si vedono delle pelli fresche tese per la conciatura. Il loro odore ricorda quello delle taverne francesi quando vi si cucinavano i gatti da servire come lepri in salmì. Le stanze sono prive di mobili e anche i ganci di legno sono stati staccati dai muri per gettarli nel fuoco come combustibile. Le pareti sono spoglie e piene di macchie e dai travetti anneriti del soffitto pendono festoni di ragnatele. Il pavimento di pietra farebbe disonore a una prigione civile. Tuttavia, anche se non ha l’aria attraente, questo luogo è molto divertente e con i suoi esempi grotteschi e il suo ‘sporco pittoresco, fa da sfondo ad alcune scene che farebbero la felicità degli amanti della pittura olandese.
Ho assunto l’identità di un pellegrino turco e con qualche difficoltà ho trovato alloggio al wakalah Jamaliyah, nel quartiere greco. Ho versato la quota per la chiave, la miftah, e un importo per l’affitto di due scomodissime stanze, famose, ho saputo in seguito, per far ammalare i loro occupanti. Ho anche pagato una somma per l’uomo che scopava e lavava il pavimento.
Nel caravanserraglio ho avuto la fortuna di ritrovare un uomo che avevo conosciuto sul battello e del quale ero diventato amico. Haji Wali, questo era il suo nome, mi aveva visto seduto in disparte e aveva pensato che fosse per l’imbarazzo, perciò si era avvicinato e mi aveva posto delle domande in modo gentile. Era un uomo dell’apparente età di quarantacinque anni, di corporatura media, con la testa grossa e rasata, il collo simile a quello di un toro, gli arti vigorosi come quelli di un sassone, la barba rossa e rada, i lineamenti ben fatti e illuminati da un’espressione di benevolenza. Era dotato di spirito caustico e si divertiva a canzonare gli altri, ma lo faceva con mitezza e in modo dimesso, così che difficilmente ci si accorgeva delle sue intenzioni ironiche.
Dopo aver scoperto la mia professione, aveva esclamato più volte, mostrando gratitudine: “Grazie ad Allah, abbiamo un dottore a bordo!”. Dapprima ero stato lusingato dalle sue calorose espressioni di riconoscenza, ma ben presto mi sono reso conto del vero significato delle sue osservazioni. Quando eravamo più in confidenza mi ha detto: “Voi dottori cosa fate? Quando un malato viene da voi per un’oftalmia, gli date una purga, gli applicate un vescicante e gli mettete una goccia nell’occhio! Nel caso in cui sia affetto da febbre, gli ordinate una purga e del chinino. Se ha la dissenteria, allora gli prescrivete ancora una purga e un estratto di oppio. Wa’llahi! Sono capace anch’io di fare il medico! – esclamava con un sogghigno – Se solo conoscessi i prezzi delle medicine, i dirham-birham, e i nomi in arabo delle malattie, pronunciando i quali si rischia di slogarsi le mandibole, potrei esercitare anch’io l’arte medica! Ma ormai siamo oberati di dottori!”. Mi ha suggerito invece di guadagnarmi da vivere insegnando le lingue.
Trovandoci sotto lo stesso tetto, ci incontravamo spesso e, dopo aver cenato insieme, passavamo la sera in una moschea o in un luogo pubblico a parlare della parte del mondo che avevo visto e di tanto in tanto a fumare i semi dell’hashish. Haji Wali era originario della Russia e i suoi vagabondaggi avevano cancellato molti dei pregiudizi tipici del suo popolo. “Credo in Allah e nel suo profeta e nulla più” ripeteva. Respingeva l’alchimia, non credeva alla magia e agli spiriti e nutriva un’avversione ben poco orientale per i racconti fantastici. E’ diventato ben presto il mio cicerone e mi ha messo in guardia dagli imbrogli dei mercanti. Mi ha consigliato di abbandonare il mio travestimento da derviscio, con gli ampi pantaloni blu e la camicia corta e, dopo aver valutato diverse alternative, abbiamo convenuto che la cosa migliore era di assumere l’identità di un Pathan, nato in India da genitori afgani, cresciuto a Rangoon, in Birmania, in viaggio sin da ragazzo, come succede spesso a queste persone. Il nuovo ruolo mi metteva al riparo dall’essere scoperto dalle persone di quel paese. Per rivestirlo, bisognava conoscere il persiano, l’arabo e l’indostano e io conoscevo abbastanza bene tutte e tre queste lingue. Nei negozi, nelle moschee e durante gli spostamenti ci si sentiva chiedere in continuazione: “Qual è il tuo nome?” oppure “Da dove vieni?”, in modo del tutto naturale e le mie eventuali lacune nelle risposte potevano essere attribuite al mio lungo soggiorno a Rangoon. Hadji mi ha anche consigliato di assumere il ruolo di un dottore itinerante che avesse fatto voto di visitare i luoghi santi dell’Islam. In questo modo, avrei dato l’impressione di voler dissimulare il mio rango e avrei ricevuto più cortesie di quante ne meritassi.
Il suggerimento era pieno di sagacia e, alla luce dell’esperienza successiva, non mi sono pentito di averlo seguito. Però, per farmi conoscere, dovevo creare un po’ di subbuglio. In Europa, i dottori itineranti si fanno pubblicità facendo sapere a tutti, ad esempio, di aver smarrito un anello di diamanti che era stato loro donato da un despota russo o pagano un giornale per far scrivere una colonna dedicata a loro da una firma ben conosciuta. Completano poi il quadro con una targa d’ottone sulla porta, l’uso di citazioni dei sermoni, un bastone con il pomello d’oro e una carrozza che annunci il loro arrivo con il rumore sull’acciottolato. Qui in Oriente, invece, la strada che porta alla gloria nel campo della scienza medica è diversa. Ci si accosta per esempio a un facchino dagli occhi cisposi, gli si versa nell’orbita qualche goccia di nitrato d’argento, sussurrandogli che non si accettano soldi dai poveri. Quando guarisce, il portatore sparge la notizia delle vostre capacità terapeutiche e i poveri cominciano ad accalcarsi davanti alla porta.
Per ripagarmi della docilità con cui avevo seguito i suoi consigli, il mio amico tesseva ovunque le mie lodi e mi presentava come la fenice dei medici. I miei primi successi li ho avuti all’interno del caravanserraglio. Gli schiavi abissini di un negriero arabo alloggiato di fronte a me si ammalavano in continuazione di dissenteria, di consunzione e di varicosi. Dapprima ho guarito una ragazza, che valeva almeno quindici sterline e il suo padrone, riconoscente, mi ha chiesto di curare altre sei giovani dal difetto di russare, che ne faceva abbassare il prezzo. Le ragazze appartenevano alla razza steatopigica dell’ Abissinia, con le spalle larghe, gli arti ben fatti e i fianchi stretti. Le loro proporzioni erano prodigiose e, anche se nessuna di loro aveva dei bei lineamenti, nei loro tratti c’era un’espressione dolce e arguta. Il modo curioso che avevano di civettare le portava a rispondere ai complimenti con la domanda: “Allora perché non mi compri?”. Quante volte anche in Occidente si intuisce la stessa domanda, seppure non espressa in modo esplicito, su labbra rosee o dentro a occhi che brillano?
La ricerca di un domestico che mi accompagnasse durante il viaggio è stata abbastanza difficoltosa. Alla fine ho optato per un ragazzo indiano, che si è poi rivelato un ladro e un codardo a Medina, quanto era stato gradasso al Cairo. Ma gli Arabi lo scambiavano per uno schiavo abissino e questo errore favoriva il mio travestimento. Inoltre, il ragazzo era un buon servitore, accettava la disciplina e dipendeva completamente da me, perché non aveva alcun altro punto d’appoggio e questo diminuiva il pericolo che mi spiasse per andare a raccontare in giro i miei affari.
Volevo anche trovare un maestro per migliorare la mia dizione e approfondire le conoscenze di teologia, con il pretesto di leggere in arabo i libri di medicina. Lo sceicco Mohammed al-Attar, ‘il Farmacista’, che aveva conosciuto tempi migliori quando era predicatore, khatib, in una delle moschee di Mohammed Ali, prima di essere congedato da Sua Altezza il Pascià, si è rivelato l’insegnante adatto. Il suo negozio, lungo cinque piedi e profondo sei, ricavato nel muro di una casa nel quartiere di Jamaliyah, era un esempio di bizzarria nilotica. Uno dei due locali divisi da un sottile tramezzo di legno con un arco intagliato per il passaggio era stipato di vecchie ceste polverose gettate alla rinfusa sul pavimento sporco. L’altro, più esterno, conteneva i prodotti in vendita. C’erano dei fornelli per pipe di argilla rossa, una stuoia piena di tabacco persiano, un sacco fatto di foglie di palma colmo di caffè di infima qualità e delle grosse zolle di zucchero avvolte in carta marrone. Gli scaffali erano ingombri di scatole di legno piene di ditate, con etichette che non corrispondevano al contenuto. Sulla cassetta del rabarbaro c’era il cartellino del pepe, su quella dell’acido tartarico c’era il cartellino dell’arsenico, su quella del sale di ammonio c’era l’etichetta del solfato di ferro.
Sopra a una scatola di forma quadrata chiusa a chiave, che conteneva gli spiccioli per il resto, alcune bottigliette di profumo danneggiate, dell’antimonio di cattiva qualità per gli occhi e del rosso velenoso era appesa una basculla in equilibrio precario. Da alcuni ganci sulla facciata pendevano delle canne per pipe, delle candele sporche e delle cartine per sigarette. Una rete logora al posto del vetro teneva lontane le mosche quando il padrone era presente e teneva lontano i ladri quando egli era assente perché era andato alla moschea a recitare lo ‘Ya Sin’. Due sgabelli sudici e coperti di mosche costituivano tutto il mobilio del mio precettore. Sono convinto che quell’uomo esile, di circa cinquantotto anni, con la testa rasata e il viso giallastro e rugoso che un tempo doveva essere stato bello, gli occhi cisposi, la barba grigia e incolta, che non aveva mai visto l’olio né il pettine, passasse i tre quarti della giornata a dormire. Il suo grosso turbante aveva cambiato colore a forza di essere usato e la giacca e la tunica erano piene di buchi. Le sue mani sembravano sporche, anche se le lavava spesso prima di pregare. Stupiva vedere quanto si mostrasse burbero e altero con i bambini che si accalcavano attorno a lui stringendo in pugno i centesimi necessari a comprare il pepe o lo zucchero. Osservavo con ammirazione il modo in cui si girava, facendo perno su quella parte del corpo che ci distingue dalle scimmie, per raggiungere un cassetto lontano o per tirare giù dallo scaffale una scatola. Come faceva a prostrarsi per dire le preghiere su quel minuscolo tappeto che non sarebbe bastato per adagiarvi un neonato? Non sapeva molto del suo lavoro e aveva pochi clienti. Il suo piacere più grande era, la sera, poter parlare con Haji e con me dei tempi in cui era un khatib, mentre sedevamo nel suo negozio a fumare e a bere il caffè dolcificato con lo zucchero del suo negozio.
In Egitto, d’estate, il mattino presto e la notte sono in genere piacevoli,, ma la tarda mattinata e i pomeriggi sono soffocanti. Il vento spande una polvere fine e spinge verso la città il caldo da fornace del deserto; il suolo restituisce con gli interessi il caldo che scende dall’alto e non una nuvola o un po’ di vapore interrompe quella tremenda distesa di luce.
Talvolta, la sera raggiungevo a piedi, con un amico, la cittadella, e mi sedevo sull’alto muro, una delle opere di fortificazione della moschea di Mohammed Ali. Godevamo di una vista che, con la luna quasi piena, aveva un incanto che non si può tradurre in parole. Scappando dalla “irrespirabile sporcizia del Cairo”, attraversavamo la Porta della Vittoria e percorrevamo la desolata distesa oltre la Città dei Morti. Seduti sopra un mucchio di rovine, inspiravamo l’aria fine del deserto, che rianima come un cordiale, con la luce delle stelle e la foschia della rugiada che rendeva diverso un paesaggio che di giorno era un vasto mare di terra gialla con ammassi di rupi di gesso, coperti da un sottile strato di sabbia che si sollevava e restava sospeso nel forte vento.
Tutto è squallido nella luce del mezzogiorno. Ma di notte, quando si vedono solo le silhouette delle case, quando la luna è alta nel cielo e le stelle d’estate alte sul mondo, c’è qualcosa di divino in ciò che si vede. Qualche settimana dopo ho preso congedo dai miei amici dicendo loro che andavo alla Mecca passando per Gedda, mentre ero ben deciso ad andare a Medina partendo da Yanbu. In questo modo, mettevo in pratica il proverbio arabo: “Dissimula i tuoi princìpi, il tuo tesoro e la tua strada.”
Ho noleggiato due dromedari da un beduino e ho assunto un uomo che se ne prendesse cura. Avevo intenzione di partire a marce forzate per verificare fino a che punto quattro anni di vita effeminata in Europa avessero diminuito le mie capacità di resistenza. Il lettore può credermi se dico che per provarlo non vi è probabilmente test migliore di una cavalcata di ottantaquattro miglia in piena estate, su di una cattiva sella di legno, a dorso di un pessimo dromedario, attraverso il Deserto di Suez, per provarlo. Neanche quel gentiluomo famoso per essere foderato di rame avrebbe disdegnato una prova simile.
Le provviste per il viaggio consistevano in tè, caffè, zucchero in pani, riso, datteri, biscotti, olio, aceto, tabacco, lanterne, pentole per cucinare, una piccola tenda a forma di campana e tre ghirbe piene d’acqua. Calcolando che i cammelli carichi impiegano di solito 55-60 ore per coprire il percorso, due giorni prima della fine dell’Id ho spedito a Suez il mio servitore indiano, insieme con il bagaglio pesante. Io ho passato il resto del tempo al Cairo con Haji Wali, che mi ha aiutato a preparare le provviste di acqua, di viveri e di tabacco e mi ha consigliato di partire intorno alle tre del pomeriggio per arrivare a Suez la sera del giorno dopo. A quell’ora, Nassar è venuto a dirci che i dromedari erano pronti.
Mi sono vestito, ho infilato una pistola nella cintola, e ho passato sulla spalla la cordicella di seta rossa dell’Hamail, il Corano tascabile, a riprova che ero un vero pellegrino. Sia Haji Wali che il mio precettore Shaikh hanno voluto accompagnarmi alle porte della città per augurarmi buon viaggio. “Allah ti benedica, Y’al-Haji, e ti restituisca al tuo paese e ai tuoi amici!” mi dicevano i conoscenti. Sono montato sul cammello, ho incrociato le gambe davanti al pomo della sella – in Egitto non si usano le staffe – e mi sono diretto verso il deserto lungo la strada in pendenza. Fuori le mura, i miei amici mi hanno salutato e mi hanno augurato un’ultima volta buon viaggio. Nel vedere le loro facce oneste e le loro figure svanire a poco a poco in lontananza, ho provato una stretta al cuore. Ma lo sceicco Nassar stava già incitando il cammello con una verga e sembrava intenzionato a prendere la testa della nostra piccola carovana. Era una prova di coraggio a cui non potevo sottrarmi, perciò non avevo tempo per le emozioni e i ricordi. Ho dato un calcio al mio dromedario, che è partito al piccolo trotto. Con una risata stridula, il beduino ha cercato di sorpassarmi, ma io ho tenuto duro e abbiamo continuato così, come dei bambini, finché i cammelli sono riusciti a correre a buona velocità. Davanti a noi c’erano ottantaquattro miglia da coprire e la temperatura era quella di una fornace. La strada era deserta, ma se qualcuno ci avesse visti correre a quel modo avrebbe pensato che eravamo inseguiti dalla polizia. Il sole a picco cominciava a far sentire i suoi effetti nefasti sugli uomini e sulle bestie e la nostra posizione alta sul suolo ci esponeva ancora di più al calore e al bagliore riflessi dalla strada asfaltata, per questo abbiamo tirato le redini e ridotto l’andatura, adottando un passo più ragionevole. Per rinfrescarsi, i beduini della carovana si sono preparati da fumare, hanno riempito il mio chibuk e ne hanno acceso il contenuto con un acciarino. Ho aspirato alcune boccate, poi gliel’ho porto ed essi l’hanno usato a turno. Per diminuire il tedio del viaggio, hanno cominciato a pormi delle domande, un passe-temps di cui non vedevo la fine, perché non erano mai soddisfatti delle mie risposte. Sembravano disposti a fermarsi solo quando avessero saputo di me almeno quanto ne sapevo io.
Abbiamo proseguito il viaggio attraverso il deserto inabitato e selvaggio fin quasi al tramonto. Il paesaggio offriva pochi elementi di diversità, ma la mente era ugualmente occupata dai pochi oggetti che si vedevano. In un paesaggio simile ogni differenza minima di forma o di colore attira l’attenzione e chiede di essere osservata. I sensi e le facoltà percettive, inclini ad addormentarsi davanti a una massa confusa di oggetti naturali, qui sono aguzzi e reagiscono vigorosamente, nel desiderio febbrile di abbracciare ogni dettaglio. Il viaggiatore solitario prova per il deserto un interesse maggiore che per i promontori marini, i ghiacciai alpini, le praterie ondulate e avverte una continua eccitazione della mente, i cui poteri sono stimolati al massimo. Sotto a un cielo terribile nella sua bellezza immacolata, nel bagliore accecante e impietoso del sole, il simùn, che lascia le sue tracce sulle mobili dune, sulle rocce scorticate, sulle montagne scheletrite, sulle pianure desolate, ti accarezza con il respiro fiammeggiante di un leone. Chi attraversa il deserto è eccitato dall’idea che la rottura di un contenitore dell’acqua o la ferita nello zoccolo di un cammello equivalga a morte sicura fra i tormenti. Cosa ci può essere di più emozionante e sublime in una terra macilenta, infestata da bestie selvagge e da uomini ancora più selvaggi, in una terra dove persino le fontane mormorano le parole di avvertimento: “Bevi e scappa lontano”?. Il cuore balza in petto al pensiero di misurare le proprie deboli forze con la potenza della Natura e uscire dalla prova vincenti. Questo spiega il proverbio arabo: “Viaggiare è vittoria.” Nel deserto dove, ancor più che sull’oceano, la morte è sempre presente e arriva con le privazioni, i saccheggi, i disastri, il senso del pericolo riveste la scena di un interesse che va al di là di essa.
Se il viaggiatore pensa che stia esagerando, provi ad abbandonare la strada di Suez per un’ora o due e galoppare in direzione nord verso le sabbie. Nel tremendo silenzio, nella solitudine e desolazione del posto, egli si renderà conto di che cosa sia il deserto, nonostante le piccole frange fertili e le belle oasi ricche d’acqua, fra le quali non si può includere il wadi al-Ward, il cui nome significa La Valle dei Fiori, ma che in realtà corrisponde a una zona piatta e dura, dove fiorisce un pugno di arbusti selvatici che lottano per portare avanti un’esistenza effimera. In questo luogo disabitato la mente viene influenzata attraverso il corpo. La bocca brucia, la pelle è inaridita, ma i polmoni sono leggeri, la vista è più luminosa, la memoria recupera il suo tono e l’umore diventa esuberante. Il carattere selvaggio e sublime del paesaggio, che richiede sforzo per viverci, il pericolo, la tensione potenziano enormemente la fantasia e l’immaginazione e smuovono le energie dell’anima. La schiavitù e la gentilezza ipocrita del mondo civilizzato sono alle spalle, si diventa schietti, cordiali, ospitali, determinati nel perseguire il proprio scopo. I sensi sono acuiti senza bisogno di stimolanti come l’alcool, che nel deserto provoca solo disgusto. Si prova un grande piacere a condurre un’esistenza puramente animale, nella quale sono essenziali l’aria e l’esercizio fisico. Il forte appetito facilita la digestione, la sabbia dove si dorme è più soffice di un letto di piume, la purezza dell’aria fa sparire molti malanni. Le persone di ogni età - dalle più materialiste a quelle più dotate di immaginazione, dal cittadino sottomesso e conformista al parroco, dalla vecchia zitella al bambino rovinato dalla civiltà - sentono dilatarsi il cuore e battere forte il polso quando contemplano lo splendido deserto dall’alto del dromedario. Non si è mai sentito di un viaggiatore che ne sia rimasto deluso. E’ un altro esempio dell’antica verità che la Natura è sempre generosa verso l’uomo, per quanto questi l’abbia trattata indegnamente. E quando ci si è abituati alla tranquillità del luogo, si soffre molto a ritornare al tumulto della civilizzazione.
L’agitazione e confusione della vita artificiale, con il suo lusso e i suoi falsi piaceri provoca ripugnanza. Lo spirito si deprime e rende difficile ogni sforzo fisico o mentale per qualche tempo dopo il ritorno. L’aria della città sembra soffocante e la vista del fisico sfatto e dell’espressione cadaverica dei concittadini rimanda al Giorno del Giudizio.
Siamo arrivati a Suez verso mezzanotte e ci siamo diretti alla stazione per riposarci un po’ al riparo delle sue mura. La rugiada scendeva abbondante e bagnava le nostre lenzuola, ma nel deserto chi si preoccupa di queste inezie? In cielo splendeva la luna, spirava una fresca brezza e il verso dello sciacallo ci faceva da ninna nanna. Quando sono apparse le prime pennellate di luce grigia che annunciavano l’alba e che i Persiani chiamano Coda di Lupo, ci siamo alzati. La foschia fluttuante sulle colline a settentrione dava al palazzo del pascià, il Dar al-Bayda, l’aspetto di un vecchio castello feudale e abbelliva il volto della Desolazione. Gli aironi della sabbia/ colombe delle rocce, i kata, si alzavano dalla strada in stormi rumorosi e una gazzella randagia camminava con grazia sulla piana sassosa. Quando siamo passati accanto all’albero dei Pellegrini ho aggiunto un lembo di stoffa allo strato di brandelli e ho invocato l’aiuto del santo Al-Dakruri dalla sua dimora color crema. Poi siamo risaliti sui nostri cammelli e abbiamo ripreso vigorosamente la marcia. La frescura dell’alba aveva lasciato il posto all’afa mattutina, più tardi il sole di mezzogiorno, col suo bagliore feroce, ha reso incandescente la pianura, ma noi abbiamo continuato ad andare avanti.
Alle tre del pomeriggio abbiamo attraversato il letto di un fiume in secca, dalla cui sabbia, coperta dalle foglie secche della Datura, emanava il profumo dolce dell’assenzio, il shih. I beduini si sono diretti verso l’ombra di una mimosa che era appena più grande di quella di una palma da cocco e si sono sdraiati a riposare, accanto a un gruppo di pellegrini maghrebini, anche loro diretti a Suez.
Dopo aver ripreso il cammino, abbiamo visto stagliarsi all’orizzonte i picchi merlati del Jabal Rahah, al di sotto dei quali si vedevano alcuni tratti del terrapieno sabbioso su cui passava la strada per Al-Hijaz. Sulla destra c’erano le larghe pendici del Jabal Mukattam, che avevamo continuato a costeggiare a partire dal Cairo. Davanti a noi c’era lo spettacolo caro a ogni Inglese: una striscia di mare scintillante solcata da un battello a vapore. I rilievi di gesso e arenaria avevano un colore rossastro sotto agli ultimi raggi del sole, le cavità in ombra un colore porpora. Ci siamo fermati vicino a un pozzo chiamato Bir Suways per abbeverare gli animali. Nell’ora serale io mi sono seduto ad ammirare il deserto, delle cui incantevoli sfumature gli occhi non si stancavano mai. Quando siamo passati attraverso alle sei aperture della porta di Suez in rovina, scendeva la sera. Il mio servitore non era ad attendermi all’arrivo, perciò sono andato a cercarlo in quasi tutti i trentasei caravanserragli della città. Non avendolo trovato, mi sono preparato a passare la notte in quello in cui avevo ritrovato un giovane arabo che conoscevo. Ho steso in terra il tappeto e sono caduto in un sonno agitato, per nulla ristoratore.
I centotrentacinque chilometri a dorso di cammello mi avevano indolenzito le ossa e scorticato la pelle e quella che non era scorticata era bruciata dal sole. Ho maledetto i quattro anni di vita in Europa, che avevano infiacchito il mio corpo, rendendolo molle. La mia preoccupazione per i bagagli era infondata perché il mattino dopo Nour, il mio domestico indiano, ha fatto la sua comparsa al caravanserraglio, insieme ad alcuni compaesani. Ha detto che la sera prima era stato invitato a una festa per lo smantellamento di un vecchio scafo a vapore. A giudicare dal suo aspetto contrito, si aspettava una punizione, che gli ho risparmiato.
Scrivo qualche parola sui miei compagni, i cui nomi ricorreranno spesso nelle pagine seguenti e comincio da Omar Effendi, originario del Daghestan o della Circassia orientale, nipote di un mufti di Medina e figlio di un capo carovana. Aveva un corpo piccolo e rotondo, un colore giallo e un temperamento bilioso, gli occhi grigi e i tratti molli. Era privo di barba, cosa che lo preoccupava. Diceva di avere ventotto anni, ma, con i suoi modi di studente, non gliene si dava più di quindici. Vestiva in modo dignitoso, pregava regolarmente e detestava il sesso femminile, come ogni vero arabo, i cui sentimenti sono sempre portati all’estremo. Aveva un aspetto serio e un contegno mite, una voce bassa e dolce, ma se lo si provocava, diventava furioso come una tigre del Bengala. I suoi genitori lo avevano spinto al matrimonio, ma lui aveva risposto loro di avere troppo poco senno, malgrado l’età, per una scelta simile. In realtà l’unico suo desiderio era quello di andare a Medina a iscriversi alla moschea Azhar come studente povero, ovvero come Talib ‘ilm. Lo accompagnava un uomo di fiducia, un negro di nome Saad, che nella sua città natale era soprannominato Al-Jinni, il diavolo, e che era stato allevato come schiavo nella famiglia di Omar. Ottenuta l’emancipazione, egli aveva fatto prima il soldato, poi il mercante, viaggiando in lungo e in largo, dalla Russia a Gibilterra a Baghdad. Era africano fino in fondo, rumorosamente allegro un momento, silenziosamente scontroso il momento dopo, affettuoso e offensivo, coraggioso e presuntuoso, imprudente e abile, litigioso e senza scrupoli. Il lato positivo del suo carattere era l’amore e il rispetto che portava al suo padrone, anche se non esitava a sgridarlo quando era infuriato e a rubargli tutto quello su cui poteva mettere le mani.
Lo sceicco Hamid al Samman portava il soprannome di ‘mercante di burro chiarificato’, che gli derivava da un antenato sufi e santo. Aveva un lungo ciuffo di capelli sulla nuca e una barba che non pettinava mai, simile a quella di un caprone. Andava a piedi scalzi e indossava un camice color ocra, molto sporco e rimboccato in vita, in una cintura di cuoio. Per non essere obbligato a tirar fuori dal baule i suoi vestiti puliti, non pregava mai e fumava solo quando riusciva a farsi dare del tabacco dagli altri. Conservava gelosamente sul petto un piccolo manoscritto con le orecchie agli angoli delle pagine, pieno di preghiere sciocche e di vecchie storie mal scritte. Di tanto in tanto lo tirava fuori, vi gettava un’occhiata, lo baciava devotamente, poi lo rimetteva a posto con il rispetto che le persone del volgo hanno per i libri. Sapeva cantare ogni genere di canzoni, sgozzare con abilità un montone, chiamare a gran voce alla preghiera, far la barba, cucinare, combattere e ingiuriare. Come Sa’ad, egli pregava soltanto quando l’atto era utile a salvare le apparenze. Alla parola vino aggrottava le sopracciglia, ma atteggiava la bocca a un’espressione di gradimento.
Salih Shakkar, un giovane allampanato nato a Medina da padre turco e da madre araba, passava le sue giornate disteso a terra a fumare il kalium persiano. Non doveva avere più di sedici anni, ma ragionava come un uomo di quaranta. Era avido, egoista e meschino, aveva l’altezzosità dei Turchi e l’avarizia degli Arabi. Lo stile che ostentava e la carnagione d’un pallore olivastro portavano gli altri a considerarlo come una persona superiore. Ripeteva continuamente il detto: “Il generoso è amico di Allah malgrado i suoi peccati, l’avaro è un suo nemico, anche se è un santo.” Lungo il tragitto siamo diventati abbastanza amici e mi ha chiesto un prestito, ma una volta arrivati a Medina, egli mi ha piantato in asso, voltandomi le spalle con la spietatezza di un londinese che incontra per caso ad Hyde Park un uomo conosciuto in viaggio sul continente, cercando di non restituirmelo.
Tuttavia, non solo lui ma anche altri passeggeri hanno ben presto cominciato a sollevare il problema di un prestito. I loro bauli erano pieni di abiti, armi, pipe, scarpe, dolciumi e altri oggetti costosi, ma fra tutti riuscivano a malapena a mettere insieme un paio di dollari per comprarsi da mangiare, pagare il trasporto e la dogana e solo la carestia più nera li avrebbe potuti convincere a impegnare il meno costoso dei loro articoli. Questo rappresentava una lezione di metafisica orientale. Ho prestato un orecchio benevolo alle loro mielose richieste di soldi perché ho intuito che la loro compagnia mi avrebbe procurato dei vantaggi. Di regola in questi paesi nessuno presta soldi, perché il prestito non viene restituito, ma il mio scopo non era quello del profitto, bensì quello di crearmi la fama di uomo generoso, di hatim, al momento della restituzione, quando avrei detto loro: “Non preoccupatevi di queste inezie!”
Dopo aver ricevuto il prestito, i miei compagni hanno cominciato a tessere le mie lodi con parole elevate. Forse tratti in inganno dal mio titolo di derviscio, hanno creduto di scorgere in me un grande personaggio in incognito. Mi hanno tempestato di domande e mi hanno offerto ospitalità a Medina e alla Mecca. Inoltre, mi cedevano il passo in ogni occasione, mi chiedevano consiglio e non intraprendevano progetti senza il mio assenso. Di colpo, Abdullah il derviscio era divenuto un personaggio di rilievo. Quando hanno saputo che il mio passaporto non era perfettamente en règle, mi hanno consigliato di farlo firmare dal governatore di Suez. Nel frattempo loro si sarebbero recati al porto per cercare posto sul primo battello in partenza per Yanbu.
Quando mi sono recato nel suo ufficio, il bey ha girato e rigirato fra le mani il mio documento come se non riuscisse a leggerlo, poi l’ha passato al suo segretario, che ne ha scoperto immediatamente l’irregolarità e mi ha chiesto perché il documento non fosse stato munito di visto al Cairo. Ha anche aggiunto che, stando così le cose, nulla avrebbe potuto convincere il bey a farmi partire. Mi restava un’unica speranza: il sig. West, vice console di Sua Maestà britannica. Mi sono recato al consolato a chiedere la sua assistenza e ho portato con me il giovane Mohammed. Un amico imprudente aveva avvertito il funzionario del mio probabile arrivo e, malgrado la mia parlata dialettale, egli ha scoperto immediatamente il mio travestimento. Si è mostrato gentile nei miei confronti e ha chiesto al suo segretario di mettersi in contatto con il factotum del bey. Ha risposto alle obiezioni di questi dicendo che si sarebbe assunta la responsabilità di rilasciarmi un nuovo passaporto come cittadino britannico valido da Suez all’Arabia. La sua fermezza ha avuto il sopravvento e il giorno dopo i miei documenti regolarizzati mi sono stati restituiti.
Mentre ero alle prese con i problemi del passaporto, il resto del gruppo era occupato a contrattare il prezzo del passaggio in barca. In quei giorni era in partenza Il Filo d’Oro, un battello di grandi dimensioni, quindi difficile da riempire, ma il suo proprietario avrebbe atteso un tempo immemorabile pur di stiparlo di merce e di uomini. Non ci restava che aver fiducia nelle manovre di Saad il diavolo, che alla fine ha trovato un accordo e ha ottenuto per noi dei posti a poppa, il posto migliore in quella stagione dell’anno. Siamo stati Ci hanno informati di un eccessivo affollamento di pellegrini maghrebini che avrebbero causato disagi, ma abbiamo pensato che: ‘Allah rende tutto facile!’.
Il giorno della partenza sulla spiaggia c’era una confusione tremenda. Chi stava per imbarcarsi sorvegliava i propri averi circondato da una folla di sfaccendati, che non avrebbe disdegnato di raccogliere gli oggetti caduti nell’operazione di carico. I pellegrini si affannavano come matti in tutte le direzioni, gli amici piangevano, i conoscenti urlavano addii, i battellieri esigevano dai ritardatari il prezzo del biglietto, i bottegai chiedevano il pagamento dei debiti, le donne strillavano, i bambini piangevano… Per quasi un’ora ci siamo trovati in mezzo a una vera tempesta umana. Per far guadagnare di più i portatori, i battellieri avevano ancorato le barche a circa sei iarde al largo. Uomini dalla pelle scura portavano a bordo le donne, sollevandole in alto sulle braccia. Queste strillavano, i loro figli gridavano perché sentivano gridare le madri, gli uomini litigavano e urlavano a loro volta, dato che in momenti simili nessuno può tacere. Appena imbarcati, poi, ognuno ha scoperto di aver smarrito qualcosa di importante: la pipa, un figlio, una cassa, un’anguria… Naturalmente i servitori, che avrebbero già dovuto essere a bordo, erano ancora tutti nei bazar.
Sulla banchina, il bey in persona esaminava i passaporti. Alcuni passeggeri non avevano i documenti in regola e hanno ricevuto una bastonatura, altri hanno dovuto tornare indietro. Verso le dieci, il nostro battello denominato Silk al-Zahab, un sambùk a vela di cinquanta tonnellate dalla chiglia aguzza e con il ponte solo a poppa ha issato le vele e, insieme agli altri, ha cominciato a scivolare lungo il canale che portava alla rada.