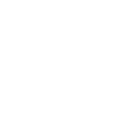DA YANBU A MEDINA
Alle sette di sera del 18 luglio abbiamo lasciato Yanbu in direzione est, lungo la piana desertica fra i monti di Radwah e il mare, dove crescevano ciuffi di erbacce che soltanto i cammelli riuscivano a mangiare e qualche acacia nana. Dalla terra sporgevano piccoli blocchi di granito e schisti di pietra verde. I dodici cammelli che formavano la nostra carovana procedevano in fila indiana, con la testa di ognuno legata alla coda di quello davanti. Soltanto Omar Effendi, che cavalcava un dromedario con decorazioni molto appariscenti per sottolineare il prestigio della sua posizione, viaggiava fuori dalla fila. Alcuni viaggiavano seduti sui coperchi delle scatole appese ai fianchi dei cammelli, mentre una donna anziana, Al-Sitt Maryam, che tornava a Medina dopo aver fatto visita alla sorella al Cairo, si era concessa il lusso di uno shibriah, un lettino legato di traverso sul carico dell’animale. Tutti gli uomini indossavano abiti miseri e sporchi - in genere una camicia a brandelli e uno straccio avvolto attorno al capo – per rispettare il voto di povertà ed erano armati, anche se il paese era sicuro. Dopo l’ultima salita, alle tre del mattino siamo arrivati al luogo di sosta, dove abbiamo scaricato i cammelli e impilato le scatole, come precauzione contro invisibili ladri. Io ero l’unico a dormire in tenda, gli altri giacevano sulle stuoie all’aperto.
La mattina seguente ci siamo alzati verso le nove e, dopo aver manifestato la gioia di trovarci di nuovo ‘nell’amato Deserto’, abbiamo avviato allegramente il fuoco per accendere le pipe e preparare la colazione. Dopo aver trangugiato in fretta un po’ di riso, un biscotto e una tazza di tè, ho ispezionato il paesaggio. Ad ovest, a circa un miglio, c’era il villaggio di al-Musahhal, un gruppo di misere capanne di fango e a sud si vedeva brillare al sole una striscia di mare. La pianura color del ferro, coperta di sassi e cavallette, con ciuffi di erba e cespugli secchi buoni solo per fare combustibile, che si stendeva intorno era costeggiata a nord da un muro di rocce nerastre. Tutto era arido, prosciugato dal caldo feroce che seccava la linfa e rendeva l’atmosfera ardente e tremolante. Le gocce di rugiada sulle pietre e sulle foglie attiravano su di esse i raggi del sole come uno specchio ustorio. Sono tornato a dormire.
Alle due del pomeriggio abbiamo mangiato del riso cosparso di burro chiarificato, delle focacce chiamate kahk, del pane raffermo, della pasta di datteri e abbiamo bevuto una bevanda dal sapore di cuoio fatta con latte acido in polvere disciolto in acqua, detta akit, molto salutare, e una grossa tazza di tè bollente alla fine del pasto. Il calore ci seccava la gola e ci costringeva a bere enormi quantità di liquido, mentre il sudore bagnava i nostri corpi come se fossimo sotto la pioggia. Vedendo passare una donna Badawi con un gregge di pecore e capre, ho espresso il desiderio di bere un po’ di latte e i miei compagni hanno mandato da lei un cammelliere con un pezzo di pane da darle in cambio di una tazza di latte, il laban.
Quando, verso le tre, eravamo pronti a partire, abbiamo visto addensarsi delle nuvole nere alle spalle del monte Radwah. Speravamo contenessero pioggia che si sarebbe frapposta fra noi e il nostro terribile nemico, il sole. Ma sulla pianura ha cominciato a spirare aria calda, carica di particelle di sabbia, che ha dato origine a una ‘tempesta del deserto’ legata, sembra, a fenomeni elettrici.
I proprietari dei duecento cammelli carichi di cereali che formavano la nostra carovana avevano l’aspetto torvo dei contrabandistas dei Pirenei. Ci scortavano sette cavalieri turchi irregolari, in compagnia dei quali abbiamo viaggiato per circa tre ore in direzione sud est, percorrendo una pianura a tratti sabbiosa e attraversata dei piccoli corsi d’acqua diretti al mare. Al tramonto, eravamo appena usciti da una macchia di acacie e di tamerici, quando abbiamo udito il grido di harami! (ladri!), che ha causato la stessa confusione che si vede sulle barche nel golfo di Napoli quando arriva una tromba marina. I cammellieri hanno impugnato i bastoni e hanno invertito la marcia, seguiti dai cavalieri, e si sono diretti verso le grida. I predoni erano solo una mezza dozzina e sono scappati via dopo qualche colpo di fucile sparato contro di loro. L’incidente, però, ha causato una grande eccitazione. Lo si riteneva un segno di malaugurio, una premonizione di qualcosa di male che stava per succedere in mezzo alle colline, dove saremmo forse stati intrappolati.
Abbiamo viaggiato per nove ore al chiaro di luna e quando ad oriente è apparsa la grigia luce del mattino siamo entrati in una fiumara larga mezzo miglio, una misyal, disseminata di ciottoli e sassi rotondi e fiancheggiata da colline quasi perpendicolari. Ne abbiamo percorso circa 34 miglia , fra crinali di roccia, gli harrah, ripidi pendii, i ria, tratti sassosi, i kitaah e pianure piatte, i sahil. Abbiamo raggiunto Bir Sa’id (il pozzo di Said) verso le otto di mattina.
Mi aspettavo di trovare un paesaggio bucolico, con fiori spontanei, limpidi ruscelli e greggi al pascolo, ho visto invece una cavità nella roccia piena di acqua torbida, una specie di grande coppa da ponce con pareti di granito, sulla cui superficie crescevano solo dei rovi a sfidare il sole. Li ho guardati con occhio invelenito. Non si vedevano case, si scorgeva solo la pianura più brulla e desolata che il sole abbia mai illuminato nella sua lunga carriera.
Mentre piantavamo la tenda il sole ci scottava i piedi. Dopo aver fatto colazione, abbiamo passato il resto della giornata nell’abituale stato di semi letargia, traspirando abbondantemente. Quando ci si trova in una situazione di disagio, si auspica sempre un cambiamento, anche se questo significa passare dalla padella nella brace. Così, appena il nostro nemico ha cominciato a scendere verso occidente, ci siamo preparati a partire. Poco dopo le tre, i cammelli sono stati caricati e ci siamo avviati, nel pieno di una tempesta di simùn, tenendo in mano una brocca d’acqua. Abbiamo camminato per cinque ore in direzione nord est in una valle desolata, formato da pianure brulle e desertiche e da enormi colline sullo sfondo, dove neanche le resistenti acacie riuscivano a vivere e dove l’erba per i cammelli non trovava un po’ di terra in cui mettere le radici. La strada serpeggiava in mezzo alle montagne e alle colline, su di un terreno accidentato costeggiato da massi di granito consumati dall’erosione, ma che sembravano modellati dalla mano dell’uomo. Le fenditure, grosse e profonde come caverne, alcune delle quali piene di sabbia, sembravano sfregi sulla superficie della terra. Non si vedevano uccelli o altri animali indicanti la presenza dell’acqua.
Verso le 11 di sera abbiamo raggiunto le poche case sparpagliate di un villaggio che ha due nomi. E’ chiamato Al-Hamra per la sua vicinanza alle sabbie rosse e Al-Wasitah perché si trova a metà strada fra Yanbu e Medina. La ricerca di un posto per accamparci ha richiesto quasi un’ora perché gli scontrosi abitanti ci scacciavano in continuazione, senza indicarci un luogo dove avremmo potuto sistemare le tende e far riposare gli animali. Dopo molti litigi, abbiamo trovato un posto adatto e abbiamo scaricato i cammelli. I miei compagni hanno disposto le proprie casse e i bagagli in cerchio, poi vi hanno steso sopra i tappeti e vi si sono coricati per proteggerli dai ladri. Sono stato invitato anche me a raggiungerli, ma la prospettiva di trovarmi in mezzo a persone ronfanti e molto sudate non mi arrideva, perciò ho declinato la proposta. Prima di addormentarmi sul tappeto disteso sulla sabbia fresca e morbida, ho sistemato la pistola con il cane rialzato sotto alla borsa da sella che mi faceva da cuscino e ho appoggiato la spada sguainata al mio fianco.
All’alba del 21 luglio, appena sveglio, mi sono accinto a visitare il villaggio, situato su di uno stretto pianoro in cima a una collina scoscesa. Le pareti delle case erano di fango e di mattoni non cotti, con aperture per il passaggio della luce e dell’aria, i tetti erano di foglie di palma. A sud della collina c’era il letto di una fiumara sabbiosa e molto ventosa, larga mezzo miglio, che nella stagione delle piogge trasportava nel Mar Rosso l’acqua di centinaia di piccoli fossi che vi sfociavano. Nei punti in cui il torrente formava delle anse il sottosuolo era ricco di acqua di buona qualità e dalle pareti rocciose sgorgavano alcune fontanelle. Le strade con le case meglio conservate apparivano densamente popolate e avevano negozi ben forniti di grano, pane, riso, burro chiarificato e altro. Una stradina stretta, lunga e polverosa, ospitava il bazar, a tratti coperto, a tratti esposto alla luce abbagliante del sole.
C’erano alcune greggi di pecore e capre che attraversavano il villaggio e, in cambio di pane e carne, ho chiesto un bicchiere di latte ai pastori che le guidavano, ma nessuno ha acconsentito a darmelo. Alla fine, ho deciso di comprare un montone di taglia media, pagandolo un dollaro, e con esso i miei compagni hanno preparato un banchetto.
La notizia che il capo dei banditi Sa’ad e suo fratello erano nei paraggi ci ha amareggiato la giornata e ci ha indotti, per prudenza, a rinviare la partenza. Il ‘Vecchio della Montagna’ mi era stato descritto come un piccolo beduino dalla pelle scura e dall’aspetto spregevole, dotato di grande coraggio e di grande intuito nello smascherare i tradimenti. Nel corso di una faida era stato avvelenato e aveva perso tutti i denti, ma era scampato alla morte bevendo una tazza di burro chiarificato. Da allora, il vegliardo viveva solo di frutta raccolta da lui e di caffè preparato con le sue mani/personalmente.
Il terzo luogo di sosta lungo la Darb Sultani , la grande strada costiera che va verso la Mecca , è Al-Hamra. Il suo clima migliore, la facilità di procurarsi cibo e acqua, la vicinanza al mare, il fatto che passi attraverso il Badr, il luogo della principale prodezza militare del Profeta, la fanno preferire dai pellegrini. Poco dopo le 4 del pomeriggio del 21 luglio abbiamo spinto i nostri cammelli ansimanti sopra alla sabbia bollente in direzione est e abbiamo raggiunto un’altra carovana, che ci attendeva dall’altra parte del letto del torrente. Abbiamo viaggiato senza incidenti per buona parte della notte, attraversando una serie di villaggi, fra i quali Bughar. Alle quattro di mattina, dopo aver percorso 24 miglia in direzione est, ci siamo accampati a Bir Abbas.
Il villaggio di Bir Abbas è formato da poche case sparse, da un misero caffè, da un paio di bazar situati dentro a baracche, da alcuni forti di pietra e da rifugi coperti di foglie di palma per i soldati a cavallo, che sorvegliavano il posto e scortavano i viaggiatori. Noi ci siamo accampati sulla morbida sabbia, che il simùn ci gettava negli occhi. Non c’era vegetazione e gli unici segni di vita erano rappresentati da sciami di mosche e da resistenti locuste. Anche se eravamo a qualche centinaio di metri sul livello del mare, il sole di mezzogiorno bruciava attraverso al tessuto delle fragili tende, che erano spesso divelte dal vento, laddove il caldo e la sabbia rovente rendevano penoso il lavoro di rimontarle. Di solito, dopo colazione i miei compagni andavano al caffè per avere notizie, ma tornavano con dei resoconti scoraggianti e passavano il resto della giornata a litigare furiosamente per un nonnulla o a stare sdraiati sulle stuoie in uno stato d’animo cupo, facendo finta di dormire.
Il 22 luglio ha rappresentato una grande prova per il nostro piccolo gruppo. Verso mezzogiorno, siamo stati raggiunti da una piccola carovana, che trasportava il cadavere di un soldato ucciso dai beduini e quello di un albanese morto a causa del sole e del vento feroce. Subito dopo ne è arrivata un’altra, composta quasi interamente da pellegrini indiani, che marciavano a tappe forzate verso la Mecca. Il motivo per cui Sa’ad il ladro compiva la buona azione di lasciarli passare indisturbati era quasi sicuramente che da tutti i portafogli dei suoi cento componenti non sarebbe riuscito a mettere insieme una sola sterlina di pedaggio, perciò la sua era una buona azione poco costosa. L’episodio non è parso incoraggiare molto i partecipanti del nostro gruppo, che avevano con sé dei beni di valore.
La sera del nostro primo malinconico giorno a Bir Abbas abbiamo udito in lontananza dei colpi di arma da fuoco. Secondo i miei compagni era in atto uno scontro fra l’esercito e gli uomini della montagna.
Alla luce della luna le cime apparivano splendide e la distanza conferiva loro un senso di mistero, in sintonia con quello che vi stava accadendo. Ho dormito dentro al shugduf, perché sarebbe stata una follia dormire all’aperto in un luogo così infestato di banditi. In queste regioni l’essere armati è una ben misera precauzione perché se ferisci l’uomo che ti sta depredando, devi pagare una grossa ricompensa, se lo uccidi, sia pure per legittima difesa, puoi dire addio a ogni possibilità di salvarti. Durante la notte sono stato svegliato tre o quattro volte dagli sciacalli e dai cani che cercavano cibo attorno all’accampamento e ho avuto modo di osservare che i compagni che si erano messi d’accordo per fare i turni di guardia dormivano profondamente. La mattina seguente, tuttavia, ispezionando gli averi, abbiamo constatato che c’erano tutti.
Il 23 luglio abbiamo dovuto fare una sosta, un contrattempo che mette sempre di cattivo umore i viaggiatori. Inoltre, il sole, la sabbia, la polvere, il simùn che soffiava furioso, la mancanza di alcuni generi di prima necessità, aggravavano le cose. Per il mio piede ferito, la signora Maryam mi aveva consigliato con insistenza un impacco di pelli di cipolla, che aveva provocato un’infiammazione. Ma ero più che mai deciso ad andare avanti con ogni mezzo disponibile, perciò ho offerto dieci dollari per un dromedario riposato che mi portasse a Medina. Lo sceicco Hamid si è dichiarato disposto ad accompagnarmi, dopo aver affidato la sua cassa a un amico. Ma l’idea che qualche membro del gruppo si sottraesse alla disgrazia comune ha fatto infuriare Sa’ad il Demonio, che ha minacciato di nascosto Mohammed di tagliare le gambe a ogni cammello che fosse giunto all’accampamento. Mohammed, che, come tutti i ragazzi del mondo, non perdeva occasione di combinare guai è venuto immediatamente a dirmelo e questo ha fatto scoppiare una lite furibonda. Sa’ad è stato sgridato dal resto del gruppo, che si è scusato a nome suo. Lui stesso si è rabbonito subito, soprattutto perché, penso, in ogni caso non vi erano cammelli disponibili.
Abbiamo passato la giornata ammucchiati sotto la tenda al riparo dal sole, non sapendo più come sistemarci per sottrarci ai suoi raggi feroci. Per passare il tempo mangiavamo, fumavamo, bevevamo o cercavamo di far raffreddare l’acqua. Al tramonto è giunta l’ambasciata che saremmo partiti quella notte, ma nessuno ha creduto alla buona notizia. Tuttavia, prima di coricarci, abbiamo disposto i nostri oggetti in modo da poterli caricare all’improvviso sui cammelli e abbiamo fatto attenzione che i beduini non facessero allontanare gli animali. Erano quasi le 11 di sera quando abbiamo udito l’auspicato suono del piccolo timpano che avvertiva le truppe albanesi che viaggiavano con noi di mettersi in marcia. In breve tempo anche noi eravamo pronti a partire. Sotto alla luce della luna che faceva capolino da dietro le rocce abbiamo attraversato velocemente la pianura sabbiosa e ci siamo uniti ad altre carovane, formando un solo grande gruppo per difenderci meglio dai temuti Hawamid.
Dopo aver attraversato la fiumara in direzione est, alle prime luci dell’alba del 24 luglio ci siamo trovati in prossimità della malfamata gola detta Shuab al-Haji, il Passo del Pellegrino. Chi stava chiacchierando a voce alta si è zittito e tutti avevano un atteggiamento che rivelava apprensione. Dalla rupe alla nostra sinistra abbiamo visto levarsi degli anelli di fumo azzurrino e subito dopo abbiamo udito le detonazioni degli archibugi, echeggiate dalle rocce di fronte. In cima alla collina è apparso un gruppo di beduini con enormi fucili, che si muovevano con l’agilità dei gatti. Si sono appostati sulle alture ‘degli assassini’ e hanno cominciato a sparare con grande facilità su di noi. L’accecamento del sole mi impediva di vederli distintamente, ma i miei compagni mi hanno indicato i punti in cui il pendio era stato tagliato per costruire una specie di parapetto difensivo, un sangah, come quelli che ci sono in Afghanistan, che servono ad appoggiare le lunghe canne degli archibugi. Era inutile sfidare i beduini a scendere dalla montagna per battersi con noi in terreno aperto ed era altrettanto infruttuoso per la nostra scorta far fuoco su di un nemico nascosto fra le rocce. L’unica cosa da fare era quella di sparare a raffica, avvolgendoci in una nube protettiva di fumo denso. Nell’attraversare la gola, tuttavia, abbiamo perso dodici uomini, alcuni cammelli e altri animali da soma.
Dopo un’ora di veloce cavalcata nel wadi Sayyalah è apparsa Shuhada:
“Like nighted swain on lonely road,
when close behind fierce goblins tread.”
Traduzione: “come un contadino, di notte, su una strada di campagna
con i folletti selvaggi che gli stanno alle calcagna.”
Shuhada significa “i martiri” e alcuni studiosi pensano che qui siano sepolti quaranta coraggiosi caduti nel corso di una delle tante battaglie di Maometto, mentre altri lo considerano il cimitero degli abitanti del wadi Sayyalah. Questa vallata, un tempo popolosa, oggi è brulla e il viaggiatore potrebbe facilmente oltrepassare il luogo sacro senza fare attenzione alle poche mura in rovina e al gruppo di rozze tombe, il cui perimetro è segnato da pietre disposte in forma ovale sotto agli alberi spinosi. Dopo un’altra mezz’ora di viaggio siamo giunti a un luogo di sosta, chiamato Bir al-Hindi perché qualche indiano vi aveva scavato un pozzo. Ma poiché volevamo mettere la maggiore distanza possibile fra le nostre tende e il covo degli Hamidah, non ci siamo fermati. Abbiamo abbandonato la fiumara e ci siamo diretti a nord lungo una strada rocciosa e in pendenza, molto battuta. Il caldo era diventato insopportabile, ma abbiamo continuato ad andare avanti, affrettando il passo. Erano le undici quando siamo giunti la nostra destinazione, una pianura accidentata coperta di sassi e di arbusti spinosi e circondata da rocce inospitali di granito e di calcare a forma di pinnacolo. Il pozzo più vicino era lontano almeno due miglia e non c’erano rifugi in vista. Sulle colline, alcuni bambini appartenenti a una tribù di beduini fuori casta, pascolavano delle capre smunte. Il luogo, chiamato “Suwaykah”, è celebrato nella storia degli Arabi, ma il motivo per cui i miei compagni ne contemplavano con amore la bruttezza era che ormai il loro bagaglio era in salvo. Con gli occhi dell’immaginazione essi si vedevano già a casa. Quella notte abbiamo viaggiato per circa ventidue miglia in direzione est su di un terreno ripido.
Abbiamo piantato la nostra tenda all’ombra traditrice di una mimosa, paragonata dai poetici beduini a un falso amico, che ti abbandona nel momento del bisogno. Ho provveduto ad infiammare quella giornata già calda con uno scontro verbale con Sa’ad il Demonio. La sua insistenza mi aveva indotto a prestargli due dollari, con i quali aveva comprato del grano ad Al-Hamra. Adesso eravamo vicini a Medina, ma lui non aveva fatto menzione di restituirmeli. Sapendo che il debitore orientale salda il suo prestito con la stessa riluttanza con cui paga l'affitto e che il creditore è capace di dedicare un anno di sforzi per riavere indietro una quota di sei centesimi, ho deciso di seguire il costume locale e di recuperare i miei averi a forza di richieste e solleciti. A mezzogiorno del giorno dopo Sa’ad il Demonio è arrivato come una furia, con il capo scoperto sotto il sole bruciante e mi ha gettato due dollari sul tappeto, ricomponendosi subito. Gli eventi successivi hanno dimostrato che avevo agito nel modo giusto: se non lo avessi costretto a pagare il debito, lui mi avrebbe disprezzato, considerandomi un novellino, e ne avrebbe approfittato.
Alle quattro del pomeriggio del 24 luglio abbiamo lasciato Suwaykah, in direzione nord-est. Eravamo così di cattivo umore che nessuno, all’infuori di Omar Effendi, ha cenato. Si sono seduti tutti per terra brontolando e fumando del tabacco siriano con aria risentita. Hanno anche dato fondo, seppure con la mia autorizzazione, alla mia riserva di sigarette Latakia.
La strada si arrampicava prima su per una collina rocciosa, poi scendeva in una valle piena di sassi. Un dromedario incespicante e saltellante aveva preso il posto della mia abituale monture, con il risultato che a ogni miglio abbiamo avuto dei vacillamenti e delle cadute.
Il 25 luglio, al sorgere del sole, non ero ancora riuscito a liberarmi dagli effetti letargici della notte precedente quando tutti attorno a me stavano già pungolando in silenzio i cammelli sul terreno ineguale. Ho chiesto se la ragione di tanta fretta fosse la presenza di predoni nei paraggi. “No – mi ha risposto Mohammed – ma i vostri compagni viaggiano con gli occhi e fra poco riusciranno già a vedere le proprie case.” Abbiamo attraversato rapidamente il wadi al-Akik, di cui il poeta ha detto:
“O my friend, this is Akik, then stand by it,
Endeavouring to be distracted by love, if not realyy a lover.”
Traduzione: “O amico, questa è Akik, perciò stai a guardare, e cerca di essere almeno turbato dall’amore, se proprio non riesci a essere un amante”
Il suo letto era coperto dalla polvere estiva e i begli alberi che vi crescevano sembravano mummificati. Mezz’ora dopo siamo arrivati a una scalinata considerata sacra chiamata Mudarraj, i cui gradini sono tagliati in una falda di basalto nero lungo la cresta occidentale dello Harratayn. Dalla cima è apparsa davanti ai nostri occhi la città di Medina. Ci siamo fermati tutti come in risposta a un ordine, siamo smontati e ci siamo seduti per terra, sfiniti e affamati come eravamo, per riempirci gli occhi della visione della Città Santa, come i devoti di un tempo.
“O Allah! Questo è il Santuario del tuo Apostolo. Fa’ in modo che sia per noi una Protezione dal Fuoco dell’Inferno e un Rifugio dall’Eterno Castigo! Apri le porte della Tua Pietà e lasciaci entrare nella Terra della Gioia!”
“O Allah, benedici l’ultimo dei Profeti, il Sigillo della Profezia, con tante Benedizioni quante sono le Stelle del Cielo e le Onde del Mare e le Sabbie del Deserto. Benedicilo, o Potente e Maestoso Signore, per tutto il tempo che i campi di grano e le piantagioni di datteri nutriranno l’Umanità!”
“Vivi in eterno, o Eccellentissimo Profeta, vivi sotto l’Ala della Felicità nelle Ore della Notte e nelle Ore del Giorno, mentre l’Uccello del Tamarisco (la colomba) piange come una donna sterile, mentre il Vento dell’Ovest spira dolcemente sulle colline del Nijd e il Lampo guizza luminoso nel Firmamento di Al-Hijaz!”
Udendo queste esclamazioni piene di poesia e di inventiva, di cui la lingua araba è ricca quando ci sono di mezzo la passione o l’entusiasmo religioso, ho capito il significato profondo dell’invito che il rituale musulmano rivolge al pellegrino: “E quando i suoi occhi si posano sugli alberi di Medina, la sua voce si alzi a benedire l’Apostolo con la migliore delle benedizioni.” Lo sguardo era colpito dai giardini e dai frutteti, alla vista dei quali era impossibile non condividere l’entusiasmo dei miei compagni. Per alcuni minuti la mia euforia ha eguagliato la loro, ma quando siamo ripartiti, lo spirito del viaggiatore aveva già ripreso il sopravvento e ho cominciato a tracciare uno schizzo della città e a fare domande sui suoi monumenti. Pensavo ormai a come mettere insieme il materiale per il capitolo seguente.
Nella foschia mattutina il sole che cominciava a sorgere dietro alle colline faceva sembrare giganteschi gli arbusti che le punteggiavano. La vasta pianura chiusa dal terreno ondulato del Nijd che si stendeva davanti a noi aveva i toni porpora e oro. A sinistra c’era la barriera rocciosa del monte Ohod, alla base del quale erano annidate nel verde una o due cupole bianche e sulla pianura piatta e scura alla nostra destra spiccavano i boschetti di datteri e i giardini verde smeraldo di Kuba, dove si allungavano delle strisce di nebbia color lilla, spesse da una parte, attraversate/trapassate dal sole dall’altra.
In basso, a circa due miglia di distanza, c’era Medina, che, a prima vista, sembrava una città molto grande, verso la cui porta, detta Ambari, aperta nel muro di fango che circondava i sobborghi, serpeggiava una strada tortuosa. A sinistra c’erano le cupole e i minareti di una graziosa takiyah turca, fatta erigere da Mohammed Alì per accogliere i pellegrini dervisci, a destra c’era una lunga fila di edifici bassi e bianchi, simili alle caserme occidentali, con brutte finestre quadrate. Dal nostro crinale si vedeva il profilo della città con le palme, le rovine pittoresche di una grande fontana e il palazzo fatto costruire nello stile di un padiglione turco dal Governatore. Nell’angolo nord occidentale delle mura c’era un forte alto e bianco, edificato in parte su di una roccia sporgente, con un aspetto moderno grazie ai bastioni e alle strombature. Nel sobborgo di Al-Manakhah, il “luogo dove i cammelli si inginocchiano”, spiccavano i minareti e le nuovissime cupole delle Cinque Moschee, luminose in mezzo alle case grigie.
Nella parte più orientale della città c’era la Gemma di Medina, con le quattro torri alte e massicce e la cupola verde brillante, sotto alla quale riposano i resti dell’Apostolo. Le tombe un po’ nascoste del venerabile cimitero Al-Bakia formavano delle macchie bianche sul fondo verde, mentre a sud c’erano le palme celebrate nell’Islam come gli ‘Alberi di Medina’.
Dopo qualche minuto di riposo siamo ripartiti lentamente in direzione della porta della città e, anche se era molto presto, la strada era già invasa da una moltitudine di persone che ci venivano incontro. Erano i parenti e gli amici dei miei compagni di viaggio, che, per poter abbracciare e baciare più facilmente i propri familiari, sono scesi dalle cavalcature. In occasioni come questa, gli Arabi mostrano più cuore degli altri Orientali, hanno una natura più affettuosa dei Persiani e dei modi più espansivi degli Indiani. Tutti si lanciavano reciprocamente fiotti di domande senza attendere la risposta, si salutavano gettando un braccio sulla spalla e l’altro attorno alla vita e appoggiando la guancia sulla clavicola destra e sulla sinistra del congiunto, poi si scostavano velocemente pronunciando un jam satis. Le persone di ceto inferiore cercavano di baciare la mano a quelle di ceto superiore, che la tiravano indietro risolutamente. Gli amici si scambiavano una cordiale poignée de main, poi si portavano alle labbra la punta delle dita e la baciavano con piacere evidente.
Dopo aver superato il Bab Ambari, ci siamo incamminati in fila indiana lungo un’ampia strada polverosa e abbiamo attraversato lo harat di Al-Ambariyah, il principale sobborgo di ManaKhah. La strada era migliore di quelle a cui è abituato il viaggiatore nelle città asiatiche. Dopo aver varcato un ponte di pietra a una sola arcata, abbiamo svoltato a destra e, dopo alcune iarde, ci siamo trovati davanti alla casa di Hamid.
Lo sceicco ci aveva preceduti per preparare le stanze destinate a ospitarci e per ricevere da solo i saluti, gli abbracci e l’esplosione di gioia della madre. Quando è uscito in strada per darci il saluto ospitale il suo aspetto era talmente cambiato da stupirmi. Sulla testa rasata 1) portava un turbante di mussola avvolto attorno a una calotta ricamata, ostentava un paio di baffi sottili girati all’insù come due virgole e una barbetta diritta e ben pettinata a forma di punto esclamativo. La camicia sporca e strappata del viaggio aveva lasciato il posto a una jubbah di lana color rosa pallido, a un caftan di un prezioso tessuto a fiori, a una bella camicia e a dei pantaloni di halaili, cioè di seta e cotone, e a una fusciacca di seta con le frange alle estremità. I piedi, bruciati dal sole, erano stati purificati e infilati dentro ai mizz e papush, le babbucce di cuoio interne ed esterne color giallo limone, di foggia costantinopolitana. In una mano teneva un rosario di madreperla, simbolo di pietà, nell’altra una bella pipa con il camino di legno di gelsomino e un costoso bocchino d’ambra. La borsa del tabacco che gli pendeva al fianco e il borsellino nella tasca sul petto della giacca erano di tessuto pettinato a doppia altezza, con ricchi ricami d’oro. Ma lo sceicco non era il solo ad aver subito una metamorfosi. Anche i miei compagni che, con saggezza, si erano vestiti di stracci quando avevano bisogno di passare inosservati, indossavano dei begli indumenti per far sapere al mondo, che giudicava la loro prosperità dalle apparenze, che il loro viaggio era stato proficuo.
Insieme ai vestiti, lo sceicco aveva cambiato anche i propri modi ed era passato dalla volgarità e dall’impetuosità turbolenta a una certa cortesia contegnosa. Mi ha preso la mano e mi ha guidato al majlis, il salone che era stato spazzato e preparato per l’accoglienza.
Per ripristinare i rapporti che c’erano prima della partenza, in Arabia c’è l’usanza della visita dei parenti e amici al viaggiatore il giorno stesso del suo ritorno. Per loro, a casa di Mohammed erano state riempite le pipe, stesi in terra i divani, messo a bollire sul braciere il caffè. Mi ero appena seduto vicino alla finestra quando i visitatori hanno cominciato ad arrivare. Lo sceicco andava a dare il benvenuto ai nuovi arrivati, che si sedevano, fumavano, parlavano di politica, facevano domande su chi era via, bevevano il caffè e dopo mezz’ora si alzavano di colpo, salutavano e uscivano. Gli uomini poco importanti entravano senza far rumore, si accosciavano nel posto peggiore, fumavano e bevevano il caffè come se lo facessero controvoglia, poi scivolavano via silenziosamente come erano entrati. Gli uomini importanti, invece, entravano con un’aria tronfia e indaffarata, un’espressione che manifestava a chiare lettere il loro benessere, facevano rumore, per indurre chi era nella stanza ad alzarsi in piedi in modo reverente. Poi si sedevano con aria di importanza, monopolizzavano la conversazione e, quando se ne andavano, tutti dovevano alzarsi di nuovo in piedi per salutarli.
Alla fine, la stanchezza mi ha fatto venir meno a una delle regole della buona educazione. Ho avuto l’ardire di informare in modo franco il mio ospite che ero affamato, assetato, stanco e desideroso di riposarmi un po’. Il buon sceicco, che si accingeva ad andare a pregare sulla tomba del padre, mi ha portato subito la colazione, ha acceso una pipa, mi ha preparato il letto, ha oscurato la stanza, ha mandato via i bambini, lasciandomi solo in compagnia di me stesso, che è la compagnia che preferisco.
Dopo il riposo, abbiamo adempiuto al dovere irrinunciabile della visita al santuario. Hamid aveva prestato a Mohammed una giacca molto vistosa, insieme ad altri capi di vestiario, e l’umore del ragazzo era molto migliorato. Lo sceicco Nur indossava il tarbush, che aveva accuratamente spazzolato, e alcuni miei abiti smessi. Con il suo abbigliamento metà turco e metà indiano aveva l’aspetto di un rispettabile schiavo abissino.
La dimora di Hamid era un piccolo edificio d’angolo, aperto verso il Barr al-Manakhah, con un vestibolo al piano terra ingombro di vecchi shudguf, materassi, pezzi di iuta e altri oggetti da viaggio in cattivo stato, e un primo piano a cui si accedeva attraverso una scala tortuosa con gradini di pietra logora coperti di terra, che comprendeva un majlis, un salone, e un magazzino collegati da un corridoio buio. Sul lato nord della casa c’era una stanza lunga e senza finestre, che conteneva un’hanafiyah, una grande vasca di rame per il bagno. Al secondo piano c’era la cucina, che non ho visitato.
Il salone aveva due piccole aperture a nord e a est, con robuste persiane di legno e avvolgibili di canne. La mattina e la sera ci sedevamo sui cuscini sistemati nelle strombature per godere l’aria fresca. Oltre al divano, gli unici mobili della stanza erano un enorme baule di legno, un tappeto e un piccolo shuffah, uno scaffale di pietra incuneato sotto a un arco del muro, sul quale erano posate delle bottiglie di profumo, delle tazzine da caffè, un paio di libri (peregrini) e un turbante sistemato fuori dalla portata dei bambini. A due ganci della parete occidentale erano appese due pistole con delle belle corde cremisi e una mezza dozzina di pipe con il camino di ciliegio. Al centro della stanza c’era una shisha, una pipa ad acqua, e in un angolo c’era un grande braciere di rame con il necessario per fare il caffè.
La casa non era grande, ma vi si godeva di una vista magnifica e questo la rendeva attraente. Dalla finestra orientale si vedevano le mura della città, le case oltre le mura, la piazza Al- Barr, la porta egizia, gli alti minareti del santuario e il monte Ohod in lontananza. Da quella settentrionale si vedeva una delle cinque moschee del quartiere, un pezzo di muro del forte e, sotto casa, l’allegro via vai dei pellegrini. Il motivo per cui mi sono dilungato a descrivere questa casa è che essa rappresenta un esempio di residenza della classe media a Medina. Le nostre giornate scorrevano piacevolmente tranquille. Il pomeriggio, quando ero sdraiato nel corridoio buio, vedevo gruppi di donne salire le scale del gineceo. A volte, qualcuna di loro si fermava a porgere ad Hamid la mano guantata, a spettegolare un po’ e a fare domande sugli amici assenti. Ma erano sempre tutte molto coperte e non si sono mai concesse di déroger alla regola del velo esponendo neanche un centimetro di guancia. In effetti, in tutto il tempo che sono stato ospite di Hamid non ho mai visto il viso di una donna, a parte quello delle due giovani schiave africane. La giovane padrona di casa stava tutto il giorno nelle stanze di sopra e non l’ho mai vista né sentita. Solo la vecchia madre di Hamid si affacciava qualche volta in cima alle scale e conversava a voce alta con il figlio o con me, quando in casa c’era poca gente. Tuttavia non è mai venuta a sedersi accanto a me per chiacchierare un po’.