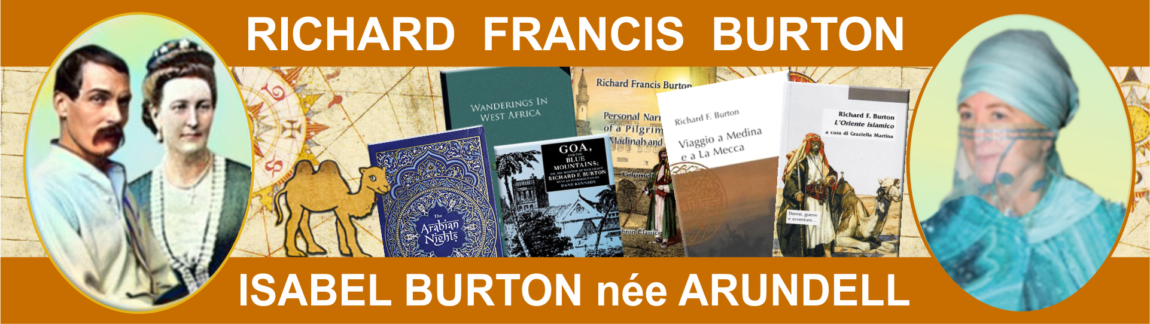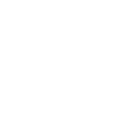Da Medina alla Mecca
Alle otto di mattina di mercoledì 31agosto, mentre eravamo seduti alla finestra della casa di Hamid, dopo aver fatto colazione, abbiamo visto avvicinarsi velocemente lo sceicco Ma’sud in compagnia del figlio quattordicenne e di un nipote, un ragazzo brutto con il viso segnato dal vaiolo. Ci ha detto di caricare in fretta gli animali e di prepararci a partire. Tutti si sono messi al lavoro e alle nove ero davanti alla porta d’Egitto, circondato dagli amici che erano venuti a prendere congedo con tutti gli onori. Dopo gli addii e gli abbracci, Mohammed ed io ci siamo sistemati nella portantina, mentre lo sceicco Nur si è arrampicato sul suo lettino. La comitiva era formata da nove cammelli, tutti di proprietà di Ma’sud, montati da alcuni abitanti della Mecca e da alcuni Turchi. Alla nostra destra c’erano dei boschetti di palme che nascondevano la città. In lontananza si scorgevano le cupole delle moschee di Hamza, ai piedi del monte Ohod.
La strada attraverso la pianura sterile e pietrosa era occupata da una folla variegata di persone, che continuavano a marciare anche nel caldo soffocante del pomeriggio. Vedevamo bestie da soma accasciarsi lungo la strada e ai lati cadaveri di asini, di cavalli e di cammelli. Gli animali abbandonati alla loro sorte servivano da festino agli avvoltoi, i rakham. Quelli a cui era stata opportunamente tagliata la gola erano circondati da gruppi di pellegrini takruri del Sudan, che tagliavano i pezzi di carne migliori, li caricavano sulle spalle e se li portavano dietro in attesa di cucinarli. Quei famelici disgraziati erano gli uomini più miserabili che avessi mai visto. Mendicavano l’acqua con delle scodelle di legno e la loro sola arma era un piccolo coltello appeso sopra il gomito, avvolto in una guaina di cuoio. Erano coperti di stracci e attorno ai piedi avevano delle strisce di cuoio. Molti zoppicavano per la fatica e per le ferite dei rovi. Portavano la morte dipinta in faccia.
Un’ora dopo il tramonto abbiamo cominciato a vedere i fuochi del nostro bivacco e a sentire delle grida che ci avvertivano che eravamo arrivati a destinazione. Subito dopo abbiamo incontrato uno degli uomini che avevamo mandato avanti e che ci ha guidati a uno spazio aperto dove abbiamo scaricato i cammelli, montato le tende e acceso i fuochi. Il campo, che sorgeva in una valle ai piedi delle colline, era molto ordinato. Attorno al padiglione dei pascià c’erano le tende dei soldati e delle guardie. Alcune sentinelle ne sorvegliavano l’ingresso. Dopo aver fatto cena, ci siamo preparati a una notte di riposo.
Durante le marce lo stile di vita è molto semplice. Noi, oltre a consumare le provviste e l’acqua contenuta nelle tasche appese dentro e fuori la lettiga, acquistavamo dei sorbetti, della limonata e del caffè caldo dai venditori ambulanti incontrati lungo il percorso. Appena arrivati nei luoghi di sosta chiedevamo le pipe, preparate con grande cura da vecchi fumatori, che, con il loro effetto deliziosamente sedativo, combinato con una tazza di caffè, procurava un appetito eccellente.
L’indomani, mentre attraversavamo il monotono e piatto kabt, ho potuto vedere la carovana nel suo insieme. A occhio, essa era composta da almeno settemila persone, chi a piedi, chi a cavallo, chi in lettiga o sui cammelli. I più poveri arrancavano appoggiandosi a dei grossi randelli, gli altri cavalcavano degli asini, dei cammelli o dei muli, secondo le proprie risorse. Le persone rispettabili, specialmente gli Arabi, montavano dei dromedari. I soldati viaggiavano a cavallo, mentre le donne, i bambini e gli invalidi indigenti sedevano sulle coperte stese sopra alle casse della soma, gli haml musattah. La straordinaria varietà di dettagli nella bardatura dei cavalli, nelle gualdrappe dei cammelli, nei vestiti degli uomini dava alla scena una bellezza meravigliosa. Un gruppo di takruri del Sudan, mezzi nudi, camminava accanto ai servitori del pascià, alcuni Persiani barbuti, con le acconciature a forma di cono, conversavano con dei Turchi rasati e con il fez in testa….
La sera, dopo aver piantato le tende, ci siamo occupati dell’approvigionamento di acqua per noi e per i cammelli, che non bevevano da novanta ore. Ma’sud diceva che sarebbero presto crollati a terra per questa privazione prolungata. I pozzi si trovavano in una fiumara a due miglia dall’accampamento ed erano controllati da soldati regolari e irregolari, che lasciavano attingere solo quelli che versavano denaro. Ma, dato che per loro quello era il solo modo di non morire di fame, non erano troppo da biasimare. Mohammed vi si è recato in compagnia di Ma’sud ed è tornato trionfante, con i nostri due otri pieni di acqua dolce pagata dieci piastre.
Prima di addormentarmi, passavo sempre almeno un’ora o due a parlare con il vecchio sceicco Ma’sud che, avendo notato il mio interesse per la sua conversazione, mi intratteneva sui suoi affari di famiglia, sulla sua genealogia e sulle battaglie a cui aveva preso parte. Il resto del gruppo non nascondeva il disprezzo nel sentire che lo interrogavo sui torrenti, sulle colline, sui beduini, sulla topografia del paese. Il vecchio Ma’sud una volta gli ha risposto: “Lasciate che il padre dei baffuti faccia domande e che impari. Egli è amico dei beduini e ne sa più di tutti voi.” La reprimenda ha avuto come unico risultato quello di suscitare un’esplosione di ilarità. Il mio soprannome, infatti, era appartenuto a Sa’ud il Wahabita, un eretico maledetto. Sabato 3 settembre l’odiato segnale della partenza ci ha svegliati all’una di notte. La marcia notturna, la sariah, è quanto di più sgradevole ci sia, ma gli Arabi sono inesorabili su questo punto. “Per i tuoi viaggi scegli il daljah, il buio del mattino – ha detto il Profeta – perché le calamità della terra (i serpenti e le bestie selvatiche) non appaiono di notte.” Il giorno dopo, domenica 4 settembre, abbiamo temporeggiato, benché lo sceicco ci avesse predetto che ci attendeva una lunga marcia. Nelle grandi carovane, c’è una specie di codice. Al primo colpo del piccolo cannone si smontano le tende, al secondo ci si mette in marcia velocemente. Anche le quattro soste di mezz’ora per la preghiera – una all’alba, una a mezzogiorno, una a metà pomeriggio e una al tramonto - sono segnalate dal cannone. L’ultima sosta è riconoscibile dalla fretta con cui i farrash, gli addetti alle tende si slanciano in avanti, per raggiungere per primi i pozzi e il luogo dell’accampamento. Tre colpi di cannone annunciano che si è arrivati a destinazione.
Gli Arabi possono essere divisi in tre gruppi.
La famiglia degli indigeni o autoctoni, si compone, secondo me, delle tribù subcaucasiche, che è possibile incontrare nella provincia di Mahrah e lungo la costa, da Mascat fino a Hadramaut; malgrado la loro inferiorità, essi sono i veri Arabi, Arab-al-Aribah.
I principali immigrati discendono della grande tribù caldea che, venuta dalla Mesopotamia, penetrò in Arabia verso il 2200 a. C., spingendo a poco a poco davanti a sé gli antichi abitatori del luogo e impadronendosi delle aree migliori della penisola. Gli Anzah e le famiglie di Nejid appartengono a questa razza caucasica pura, che corrisponde agli Arabi arabizzati degli storici orientali, gli Arab al-Mutarribah.
La terza famiglia, altrettanto nobile e antica, si può far risalire al 1900 a.C. ed è designata nella Storia sotto il nome di Ismaelita. Questi Arabi non hanno mai varcato i confini delle montagne del Nord-Ovest. Essi vi abitano ancora e conservano i costumi selvaggi e lo spirito indomito dei loro antenati. Hanno i tratti caratteristici degli uomini della valle del Nilo e questa mescolanza di sangue egiziano li distingue dagli altri. Sono dei subcaucasici per metà Arabi, gli Arab al-Mustarribah.
L’etnografia orientale riconosce come appartenenti alla quarta razza quelli che si sono mischiati ai barbari, gli Arab al-Mustajamah. Quelli della Mecca, che si sono mescolati agli Himyariti, agli Yemeniti e agli Ebrei sono di questo gruppo.
La parte migliore del carattere dei beduini è un insieme veramente nobile di determinazione, gentilezza e generosità. Essi sono un misto di furbizia e di semplicità, suscettibili ma benevoli, solenni, dignitosi e austeri, ma anche amanti degli scherzi e resi facilmente trattabili da una risata o da una parola di bontà. Sono altrettanto vendicativi per un’ingiuria. Di loro si può dire che
que s’il ne violoit, voloit, tuoit, bruloit
ne fut assez bonne personne.
Traduzione: “Se solo non violentassero, rubassero, uccidessero, bruciassero,
non ci sarebbero delle persone migliori di loro”. I beduini formano una specie di societé léonine in cui domina il più coraggioso, il più forte e il più astuto. Il secondo legame è la vendetta, temuta per la posterità anche dal più intraprendente di loro. Nel deserto la legge del Corano non è sufficiente e non è rispettata. I combattimenti sono in genere delle scaramucce che finiscono alla prima carica e i vinti fuggono protetti dalle ombre della notte. Quando viene proclamata la pace, i cadaveri vengono compensati con dei soldi. I beduini tuttavia non sono affatto dei vigliacchi. Le razzie, le vendette, l’incertezza dell’esistenza, il deserto, la caccia, la vita dura, l’uso continuo delle armi li hanno abituati a guardare la morte in faccia, da uomini che, se necessario, diventeranno eroi. Si dice che gli Inglesi combattano volentieri per la libertà, i Francesi per la gloria, gli Spagnoli per la religione e l’onore e gli Irlandesi per il gusto di battersi. Ma è l’amore per la vittoria e per la vendetta che guida la spada degli Arabi e sono l’onore e il fanatismo a farli diventare fermi e risoluti. Gli insulti delle donne e la paura di essere disonorati e considerati dei codardi li rendono capaci di azioni insensate. L’ostinazione prodotta dalla religione dà al loro spirito una fermezza impossibile da raggiungere con il solo entusiasmo. La loro storia abbonda di testimonianze a questo proposito.
Ci sono due cose che addolciscono la loro ferocia: i rapporti con la gente di città e la considerazione in cui tengono le donne. Per tutti i musulmani, Fatima non è mai stata infangata dal peccato ed è sempre rimasta vergine, anche dopo aver messo al mondo Hassan e Hossein. La vita pastorale dà luogo a incontri e separazioni da cui nascono delle passioni esaltate, che portano gli amanti a sfidare ogni pericolo. Nei poemi arabi non vi è nulla di più tenero e di più patetico delle descrizioni delle lunghe assenze e si potrebbe attribuire ad essi, oltre che alle nostre poesie cavalleresche medioevali, l’origine dell’amore puro ed esuberante dei moderni.
Le canzoni di Antar stabiliscono che “il cavaliere dei cavalieri” ama Ibla, non solo perché ella risplende come il sole all’alba, perché ha i capelli neri come le ombre di mezzanotte e il paradiso negli occhi, ma anche per la sua fede, la sua purezza e la sua tenerezza. In lei l’eroe cerca le qualità morali, oltre a quelle del corpo. Ancora oggi i discendenti di Antar sono dei perfetti gentiluomini, ma, nell’antichità, i beduini erano dei veri cavalieri erranti, che passavano anni a sospirare e a compiere fatti d’arme straordinari nella speranza di toccare l’animo della donna amata. A questo proposito si racconta un aneddoto. Il califfo Al-Mu’tasim aveva inteso dire ai suoi cortigiani che una donna della famiglia di Said, fatta prigioniera e picchiata da un barbaro greco di Ammoria, aveva gridato: “Aiuto! Mu’tasim!”. Il rozzo buffone l’aveva schernita dicendo: “Aspettalo, sta per arrivare sul suo cavallo pezzato!” Il principe si è alzato, ha messo il sigillo sulla coppa di vino che stava bevendo e ha giurato di essere pronto a fare il suo devoir di cavaliere. L’indomani, egli partiva per Ammoria, alla testa di settantamila uomini su cavalli pezzati. Dopo che i soldati avevano circondato la città, egli è entrato gridando: “Labbayk! Sono qui, in risposta al tuo appello!”, ha tagliato la testa di quel vigliacco e ha liberato la bella. Dopo di che ha ordinato al coppiere di portargli la coppa che aveva sigillato e l’ha vuotata dicendo: “Adesso, in verità, il vino è buono!”
Simili tratti di carattere spiegano l’attrazione che il beduino esercita sul viaggiatore che lo sa comprendere. Ecco perché il dottor Wallin, abituato ai sentimenti elevati e cavallereschi dei veri figli del deserto, deplora la propria sfortuna nel non trovarli presso i Persiani o gli Arabi di città. I loro costumi, le loro regole, il loro carattere, i loro bisogni sono ancora quelli degli antenati e, come il loro paese e il loro clima, essi sono anteriori alla venuta del Profeta ed esisteranno ancora quando ogni vestigia della Kaaba sarà sparita. Non mi stupirei se, fra le tribù che errano al limitare del grande deserto, sopravvivesse qualche forma di idolatria.
“Noi non partecipiamo alle preghiere – dicono - perché l’acqua delle abluzioni ci serve per bere; non facciamo l’elemosina, ma la chiediamo; non osserviamo il digiuno durante il ramadan, perché digiuniamo già tutto il resto dell’anno; non andiamo in pellegrinaggio alla Mecca perché l’intero universo è la casa di Dio.”
Per vivere sicuro in mezzo a loro, il viaggiatore non dovrà farsi vedere a disegnare in pubblico e dovrà limitarsi a scrivere delle formule magiche. Dovrà essere prudente nel porre loro domande, evitare di avere delle belle armi, perché esse inducono in tentazione più dell’oro e accontentarsi di avere un orologio di cuoio. Dovrà scegliere un compagno non troppo coinvolto nelle vendette, che accetti una piccola somma che ne assicuri la fedeltà. Costui verrà invitato sovente a dividere il pasto perché molte tribù ritengono che ‘il legame di sale’ debba essere rinnovato tutti i giorni, per impedire che esso scompaia dallo stomaco. Il viaggiatore non troverà difficile vivere in mezzo ai beduini: “Affidati al loro senso dell’onore e sarai sicuro, affidati alla loro onestà e ti ruberanno anche i capelli che hai in testa.”
Le tribù non obbediscono agli sceicchi e, nella loro società leonina, la giustizia è amministrata con la spada.
Le relazioni fra le tribù dell’Hedjaz sono di tre specie.
Vi sono le tribù amiche, ashab, unite da un’alleanza offensiva e difensiva, che si sposano fra di loro.
Vi sono quelle ostili, kiman, che si fanno vendetta e sono divise da un’inimicizia mortale.
Vi sono le tribù fraterne, akawat, che riconoscono il legame fra i beduini, che hanno i diritti sul territorio in cui i loro antenati pascolavano le pecore, e il viaggiatore che lo attraversa.
Con il pagamento di un piccolo pedaggio, questi acquisisce il diritto di passaggio e la protezione. Anche chi abita in città o nei villaggi e non può più dirsi appartenente alla tribù deve sborsare soldi. Chi tenta di passare senza versare la akawak, deve aspettarsi di essere depredato o ucciso, se oppone resistenza. Pagare non è un disonore e chi rifiuta di adeguarsi si mette dalla parte del torto. I confini del territorio rimangono generalmente gli stessi perché, anche nel caso in cui venisse massacrato un intero clan per la conquista di una regione, basterebbe che restasse in vita un solo ragazzo, perché questi, diventato uomo, torni un giorno con l’aiuto di compagni a reclamare la terra degli antenati.
Il beduino è astemio e frugale, capace di vivere per sei mesi con un po’ di latte di cammella e di burro chiarificato e qualche dattero. Disprezza le persone obese e quelle che non sanno fare a meno di un abbondante pasto regolare. Dorme su una stuoia, esposto al freddo per un quarto dell’anno e al caldo opprimente per gli altri tre quarti. Quando non ha altro, mangia le locuste bollite, messe a seccare al sole, e condite con sale e pepe. Il cibo preferito durante il viaggio sono le strisce di carne secca e le palline di latte indurite messe a sciogliere in acqua.
Al-Suwairkyah appartiene allo sceriffo della Mecca e dista 99 miglia dal luogo di sepoltura del Profeta. La città è formata da un centinaio di case e sorge ai piedi di una formazione basaltica, che si eleva solitaria nella pianura. La parte bassa della città è protetta da un muro di fango, con le solite torri semicircolari. Il giorno del nostro arrivo, il bazar era ben fornito di carne di montone, di grano, di orzo e di datteri e noi abbiamo deciso di fare una piccola festa. Abbiamo comprato dei datteri freschi e una pecora viva. Il piacere però è stato guastato dal gusto salmastro dell’acqua. Il mattino dopo, siamo partiti alle 10 in direzione sud est. Il vento soffiava forte nella valle che attraversavamo. Un pellegrino della nostra carovana, ferito, è stato avvolto in un sudario, sistemato in una fossa scavata a metà e lasciato lì a morire. Era impossibile non provare orrore all’idea di un simile destino. Il tormento della sete, il sole che ti brucia il cervello e ti porta alla pazzia, gli attacchi degli sciacalli e degli avvoltoi, che non aspettano di certo che si sia morti…
Alle 6 del pomeriggio abbiamo percorso una cresta pericolosa, poi abbiamo attraversato un enorme campo di rocce basaltiche, in mezzo alle quali siamo passati con grande difficoltà. Alle 9 siamo arrivati al villaggio di al-Sufayna, composto da una sessantina di case di fango con il tetto piatto, circondato da palme da dattero e di coltivazioni. Avremmo dovuto accamparci per la notte, ma abbiamo trovato lo spazio occupato dalla carovana di Baghdad, scortata della tribù degli Agayl e dai fieri montanari dello Yabal Shammar. Poco dopo, abbiamo udito dei colpi di moschetto accompagnati dal poco rassicurante suono dei tamburi. I miei compagni sono corsi a informarsi sul motivo dello scontro e sono venuti a sapere che la carovana di Baghdad, formata da non più di duemila persone, comprese le donne e i bambini, aveva voluto dimostrare a quella di Damasco di essere disposta a battersi pur di non cedere di un pollice il proprio diritto di precedenza. Non ho mai visto delle persone più bellicose di quelle da cui eravamo circondati. Bastava un piccolo sguardo a provocare uno scontro. Un Wahabita si è messo di fronte a me e ha fatto dei gesti d’insulto, mostrandomi i pugni per l’avversione al chibuk che stavo fumando con un compagno di viaggio. Noi non abbiamo saputo resistere al desiderio di rispondere alla sua insolenza e gli abbiamo offerto, con un sorriso cortese, un tiro dall’odiata pipa. Senza esitare un attimo, ha estratto il pugnale, ma lo ha prontamente rinfoderato quando ha visto le nostre pistole cariche puntate su di lui.
Scendeva la notte quando abbiamo finito di montare l’accampamento. Il povero Ma’sud, è andato a cercare l’acqua per le sue bestie assetate e gemebonde. È tornato in uno stato di profondo abbattimento, per aver dovuto versare quaranta piastre – otto scellini - ai soldati di guardia al pozzo.Dopo una confortevole notte di sonno, siamo ripartiti il mattino seguente alle 5.30, in direzione sud est. Abbiamo attraversato un luogo di morte, pieno di rocce nude e desolate, con un orizzonte popolato da miraggi. Alle 4.30 del pomeriggio, abbiamo udito dei colpi di fucile che ci hanno indotti a fermarci. Siamo ripartiti con il buio, ma i cammelli inciampavano in quel luogo accidentato chiamato wa’ar, facevano cadere il carico e gli shugduf restavano impigliati nelle spine dei rovi. Sembrava insensato viaggiare di notte in quelle condizioni, ma i cammelli erano ormai troppo esausti per riuscire ad affrontare il caldo del giorno. Il pomeriggio del 7 settembre siamo andati avanti sotto una pioggia battente e il giorno dopo abbiamo attraversato una pianura coperta di alberi spinosi. Gli shugduf venivano trascinati a terra insieme ai loro occupanti urlanti. Abbiamo fatto sosta a Birkat per cinque ore e, poco dopo, siamo entrati in una grande fiumara, che abbiamo percorso fino alle 6 del 9 settembre.
Quando l’abbiamo lasciata e siamo arrivati ad al-Zaribah, la valle, in molti punti ricca di verde, abbiamo abbandonato i nostri abiti da viaggio e ci siamo preparati alla cerimonia di al-Ihram, la vestizione dell’abito del pellegrino. Fra la preghiera di mezzogiorno e quella del pomeriggio, un barbiere ci ha rasato la testa, ci ha tagliato le unghie e accorciato i baffi. Poi, dopo aver fatto il bagno, ci siamo profumati – su questo punto ci sarebbe da ridire - e ci siamo rivestiti con due pezzi di cotone lunghi sei piedi e larghi tre e mezzo, di colore bianco con delle sottili strisce rosse e una piccola frangia. Al Cairo questo costume è chiamato eddeh. Uno di questi due teli, il rida, era gettato sulla spalla sinistra e, lasciando nudi la spalla e il braccio destro, era annodato sul fianco destro. L’altro, lo izar, era avvolto in vita e copriva il corpo dalla cintura al ginocchio. Questo abito religioso, che è molto scomodo, risale a tempi molto lontani.
Lo sceicco Abdullah, che era il direttore delle nostre coscienze, ci ha esortati a comportarci da buoni pellegrini, evitando le liti, le azioni immorali, le parole sguaiate e le conversazioni frivole. Dovevamo rispettare la vita, evitare di uccidere la selvaggina e persino di farla fuggire. Se avevamo bisogno di grattarci, dovevamo farlo con il palmo della mano aperto, per non uccidere i parassiti del corpo e per non strappare i peli con le unghie. Dovevamo rispettare la natura, non dovevamo abbattere alberi né strappare fili d’erba. Non potevamo usare gli oli, i profumi e gli unguenti, non dovevamo lavarci la testa con infusi di foglie di malva e di giuggiolo. Non potevamo coprire i piedi e il capo, anche se non era proibito approfittare dell’ombra o ripararci dal sole con le mani. Per ogni infrazione a queste regole dovevamo sacrificare un montone.
Abbiamo lasciato al-Zaribah alle 3 del pomeriggio, in direzione sud est. Il colpo d’occhio sulla pianura era veramente magnifico. La strada era invasa da una folla di pellegrini con gli abiti immacolati e le teste rasate di fresco che brillavano al sole. Le rocce echeggiavano del grido di: “Labbayk! Labbayk!” (Mio Dio eccomi!), urlato a gran voce anche da un gruppo di montanari Wahabiti dall’aria selvaggia e feroce, con i capelli attorcigliati in sottili trecce, i dalik. Ognuno di loro portava una lunga lancia, un moschetto e un pugnale ed era seduto su delle rozze selle legno, senza cuscini né staffe.
Le donne non avevano il velo e molte di loro emulavano gli uomini guidando loro stesse i dromedari. Il loro comportamento non era quello di appartenenti al sesso debole. In testa al gruppo marciavano un suonatore di tamburi e un portastendardo, la cui bandiera verde portava scritta in grossi caratteri bianchi la formula della fede islamica. I Wahabiti non erano dei compagni di viaggio piacevoli. Molte delle loro bestie da soma, cariche di acqua, foraggio, combustibile e altre cose necessarie alla marcia, erano slegate e provavano piacere a irrompere con furia fra gli animali della nostra fila e a creare una grande confusione. Inoltre, ogni volta che ci vedevano fumare, ci maledicevano a voce alta e ci accusavano di essere degli infedeli e degli idolatri
Alle cinque siamo entrati nel vasto letto della fiumara piena di alberi spinosi e già immersa nelle prime ombre della sera. Quando abbiamo cominciato ad attraversare un canale alla cui sinistra c’era un precipizio, lo scoramento è sembrato impadronirsi del nostro animo. Ci stavamo avvicinando alla Valle Pericolosa. Non si udivano più le voci delle donne e dei bambini e a poco a poco si erano spente anche le invocazioni dei pellegrini. A un tratto, il mio sguardo è stato attirato da un piccolo cerchio di fumo sopra a una collina. Subito dopo, è giunta l’eco di un colpo di fucile e il dromedario che trottava davanti a me è rotolato sulla sabbia, con il cuore trapassato da un proiettile. Il suo cavaliere era stato catapultato a quattro o cinque iarde di distanza.
È seguita una confusione terribile. Le donne urlavano di terrore, i bambini piangevano, gli uomini sbraitavano e tutti si sforzavano di spingere il proprio animale il più lontano possibile da quel luogo di morte. Ma la strada era stretta e si è ben presto bloccata completamente. Ogni sparo faceva fremere di spavento il grande corpo della carovana, come quando uno strumento chirurgico tocca un nervo sensibile. I cavalieri irregolari galoppavano avanti e indietro, gridando e dando degli ordini contradditori; il pascià aveva fatto stendere il suo tappeto ai piedi del precipizio e discuteva il da farsi con i suoi ufficiali fumando la pipa.
A questo punto ho veramente apprezzato la condotta dei Wahabiti, arrivati al galoppo sui loro cammelli, con le trecce al vento e le torce accese, disegnanti una luce sinistra sui loro volti. Una parte ha preso posizione e si è messa a sparare sui briganti Utaybah, mentre un altro gruppo di duecento o trecento è sceso da cavallo e si è inerpicato di corsa su per le rocce. Erano guidati dallo sceriffo Zaid, celebre per il suo coraggio, che aveva promesso di scortarci fino alle porte della Mecca. Ben presto il rumore della sparatoria si è allontanato, segno che i banditi erano in fuga, e la colonna si è rimessa disordinatamente in marcia. C’è voluta tutta l’abilità dello sceicco Ma’sud per tirarci fuori sani e salvi da quel posto. Non sono riuscito a verificare il numero dei morti e dei feriti, perché i resoconti erano contradditori ed esagerati, ma ci sono state delle vittime e molti bagagli sono andati perduti. Si diceva che gli Utaybah, il cui obiettivo era quello di derubarci e di appropriarsi dei cammelli per mangiarli, ma anche quello di poter dire in seguito: “Quella notte, nel passo, abbiamo bloccato per un’ora la carovana del Sultano!”, fossero centocinquanta.
All’inizio della scaramuccia, avevo messo mano alle mie pistole e mi tenevo pronto a servirmene, ma ben presto mi sono convinto che non c’era alcun bisogno del mio aiuto. Allora, desiderando produrre qualche effetto, mi sono messo a gridare a voce alta di portarmi da mangiare. Lo sceicco Nur, esanime per la paura, era incapace di muovere un dito. Il giovane Mohammed si è limitato a mormorare: “Oh, Signore!” e le persone intorno hanno esclamato indignati: “Per Allah, in una situazione simile lui pensa a mangiare!” Solo lo sceicco Abdullah, da uomo di spirito, si è divertito e mi ha domandato: “E’ questo il modo in cui si comportano gli Afgani, Effendi?” “Sì – ho risposto a voce alta – nel mio paese preferiamo mangiare prima dell’attacco dei briganti, perché quella gente ha l’abitudine di mandarti a letto senza cena.” Lo sceicco è scoppiato a ridere rumorosamente, ma quelli che lo circondavano avevano un’espressione offesa, perciò ho pensato che la mia bravata era stata mal placée. Ma più tardi, un piccolo incidente sulla strada per Gedda è venuto a provarmi che la mia battuta non era stata un fallimento totale.
Alle 8 di mattina del 10 settembre avevamo percorso 24 miglia da al-Zaribah. Eravamo ancora nel letto, a tratti fangoso e quindi pericoloso per le cadute, della fiumara. Dopo una sosta di quattro ore, in cui abbiamo mangiato melograni e datteri freschi, siamo ripartiti in testa alla carovana. All’una di notte sono stato svegliato dal grido di: “La Mecca! La Mecca! Il Santuario! Labbayk!” accompagnato da singhiozzi. Ho guardato fuori dalla portantina e ho percepito alla luce delle stelle del Sud la sagoma indistinta di una grande città, un’ombra più scura del resto della pianura. Alle due del mattino, siamo arrivati nel sobborgo detto Ma’abidah, e ci siamo fermati davanti alla porta della casa dove vivevano i genitori di Mohammed.